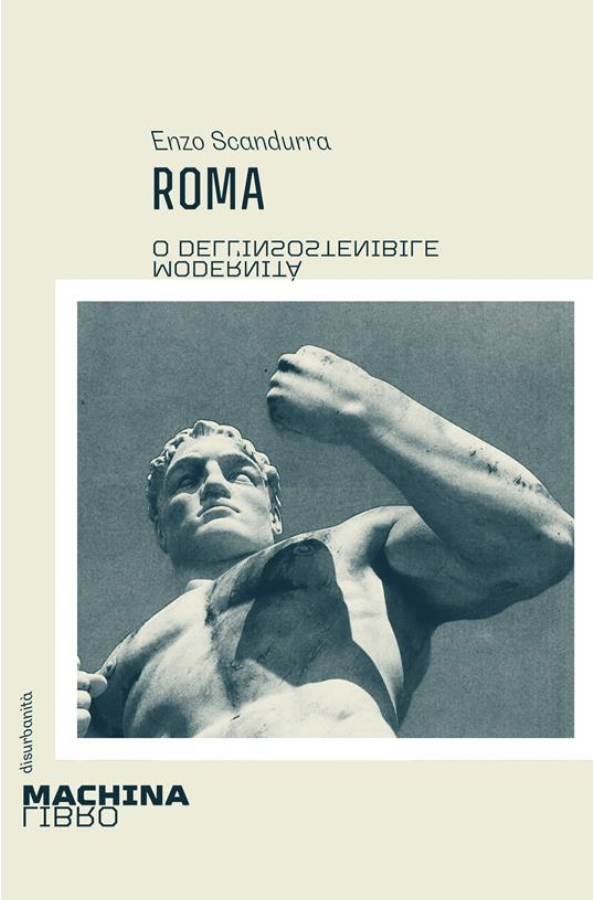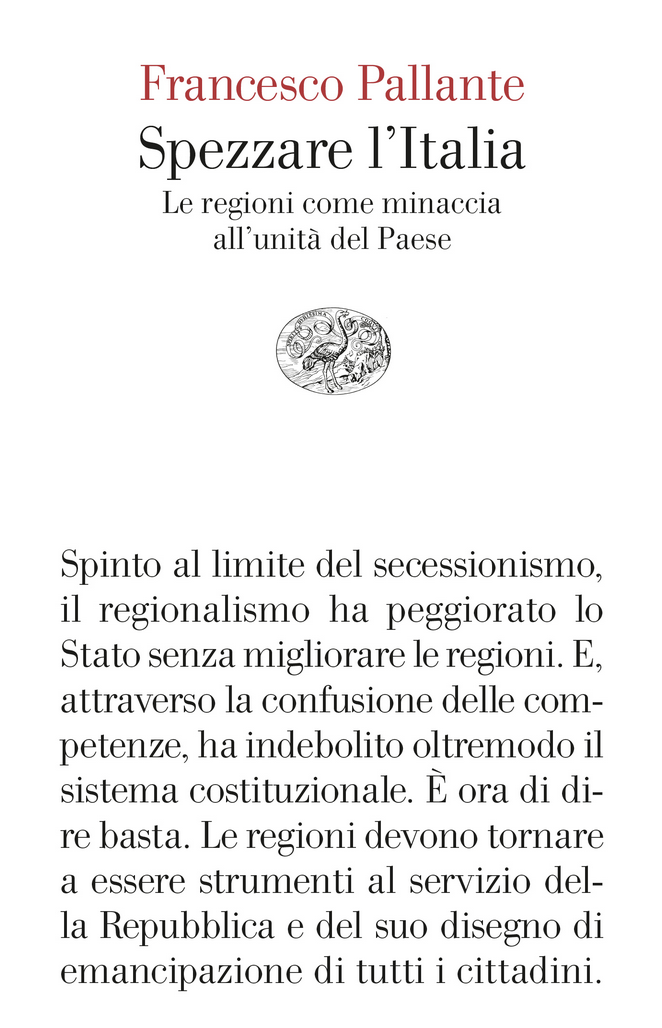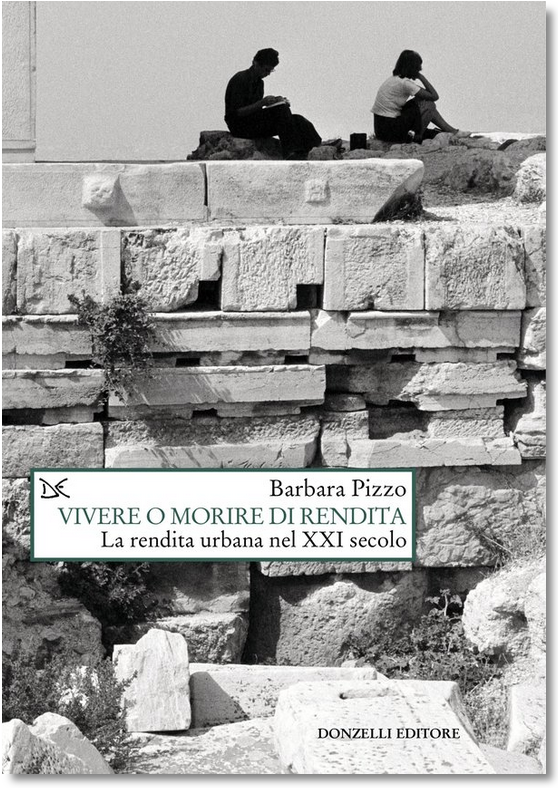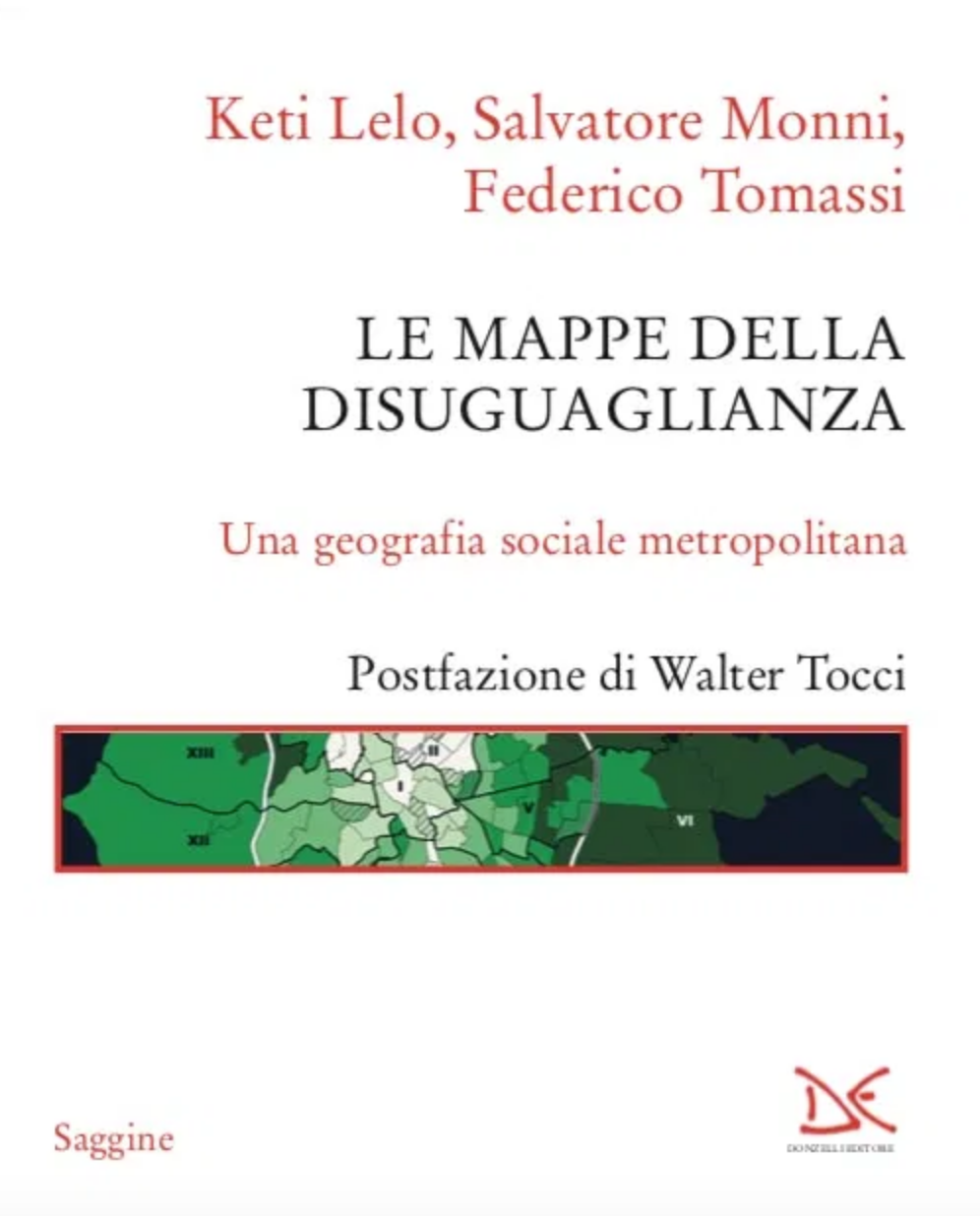Un imprenditore giapponese, Yuzo Yagi, ha finanziato con due milioni di euro il recupero della Piramide di Cestio, a Roma. Così, finalmente, è stato possibile restaurare uno dei più insigni monumenti legati all’egittomania scoppiata nell’Urbe all’epoca di Augusto: pochi giorni fa, Yagi ha visitato l’esemplare cantiere, e la fine dei lavori è prevista per il novembre di quest’anno. Già così sarebbe un’ottima notizia. Ma diventa letteralmente esemplare quando si esaminano i dettagli dell’operazione, e soprattutto quando si conoscono le richieste dell’imprenditore orientale.
Nel 2010 questi contattò il Ministero per i Beni Culturali chiedendo di poter contribuire a restaurare un pezzo di Roma antica. Non aveva preferenze, mister Yagi: chiedeva di essere utile. E al Mibac hanno avuto l’intelligenza di affidarlo a una delle nostre migliori funzionarie: l’archeologa Rita Paris, esemplare direttore del Museo Nazionale Romano e angelo custode dell’Appia. È da questo incontro che è nata l’idea di non concentrarsi sui più ovvi luoghi da cartolina, ma di indirizzare questa insperata risorsa dove c’era più bisogno: e quando Yagi ha scoperto che a Roma c’è anche un po’ di Egitto, se n’è subito innamorato ed è stato felice di dare un milione. Ma non basta: la soprintendenza archeologica è stata così brava da finire questo primo lotto di restauro con ben 150 giorni di anticipo. E poi è stata così premurosa da comunicare a Yagi che con un altro milione tutta la Piramide sarebbe potuta tornare candida: una spiegazione così convincente che nel dicembre del 2013 si è stipulato il secondo contratto.
Contratto – e questo è il cuore di tutta la storia – che non prevede alcuna contropartita, se non un pubblico ringraziamento e una targa vicina alla (e non sulla) Piramide. Avete capito bene: quando il Mibac ha chiesto al signor Yuzo Yagi cosa volesse in cambio, si è quasi offeso. In effetti, aveva detto a chiare lettere che voleva donarli, quei soldi: ma da noi in Italia va di moda confondere il mecenate e lo sponsor.
Una confusione tipica di quello che Salvatore Settis chiama il «patriottismo for profit», un affollato ‘movimento culturale’ il cui motto è che «il patrimonio culturale si salva solo con i privati». Un motto ambiguo, che mescola e confonde mecenati e sponsor, donazioni e gestione, imprese e terzo settore, concessioni e volontariato. Invece, è importante distinguere: un conto è chi vuol donare qualcosa alla collettività, un conto chi vuole guadagnare associando al proprio marchio un valore immateriale (l’immagine del Colosseo, per dirne una) che appartiene alla collettività. E mentre discutiamo dei limiti entro i quali possiamo pensare ad accettare le sponsorizzazioni, le concessioni e altre forme di privatizzazione, potremmo forse cominciare a incentivare il vero mecenatismo con una legislazione simile, per esempio, a quella francese. Se lo Stato italiano facesse la sua parte, cioè se assolvesse ai suoi doveri tutelando davvero il paesaggio e patrimonio della nazione, potrebbe poi promuovere credibilmente una campagna culturale e fiscale per suscitare un vero mecenatismo: che non puoi mai essere sostitutivo, o suppletivo, ma semmai aggiuntivo.
Il contrario, insomma, di ciò che accade ora: quando uno Stato col cappello in mano è costretto a svendere il valore immateriale – e cioè la funzione civile – del patrimonio a sponsor in cerca di contropartite che nessun paese occidentale concederebbe. Esistono in Italia dei mecenati? Esistono: l’americano David W. Packard, che per salvare Ercolano ha creato il Packard Humanities Institute, «fondazione filantropica, con lo scopo di sostenere lo Stato Italiano, attraverso la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, nella sua azione di salvaguardia di questo fragile sito archeologico, dal valore inestimabile». O Isabella Seragnoli, che a Bologna sostiene discretamente il rapporto tra arte e società. E il nostro Yuzo Yagi, naturalmente. E come loro ne esistono certo ancora altri: ma pochissimi. Per non parlare di un mecenatismo diffuso, dal basso. Il Louvre ha lanciato la raccolta di fondi per il restauro della Nike di Samotracia con lo slogan «Tous mècénes», tutti mecenati: e in quattro mesi ha messo insieme un milione di euro attraverso 6700 donatori, i cui nomi si possono leggere in internet. In Italia, invece, non c’è traccia di un crowdfunding organizzato e articolato che possa contribuire non a espropriare, ma invece, a restituire il patrimonio ai cittadini. Ma nessuno dona volentieri il proprio denaro a un’impresa altrui: i newyorkesi, generosi con il Metropolitan Museum o con Central Park, non lo sarebbero ovviamente con la General Electric. E dunque una simile svolta potrebbe avvenire solo esaltando il valore morale, e non già economico, di quel patrimonio. Imboccando la via del patrimonio come «petrolio d’Italia» ci siamo preclusi quella del patrimonio come bene comune.
Ma non è tardi per cambiare strada, e il sorriso timido di questo imprenditore giapponese potrebbe e dovrebbe ispirarci a farlo. Come ha detto Rita Paris, intervenendo al recente convegno promosso dall’Associazione Bianchi Bandinelli su Archeologia e città a Roma: «Eventuali privati che vogliano sostenere con contributi economici il patrimonio possono collaborare a una graduale, importante rivoluzione culturale. Oltre a contribuire alla conservazione di una parte fondamentale del patrimonio dell’umanità possono partecipare ad innalzare il livello civile della città, a rendere l’Italia un punto di riferimento mondiale per nuovi temi e innovazioni. Questo deve accadere non per la carenza di risorse dell’amministrazione pubblica, ma per consentire anche a privati di partecipare a una grande impresa culturale, che s’intende sempre di esclusivo interesse pubblico e condotta con le modalità della gestione della cosa pubblica (come è avvenuto per la Piramide di Caio Cestio)».