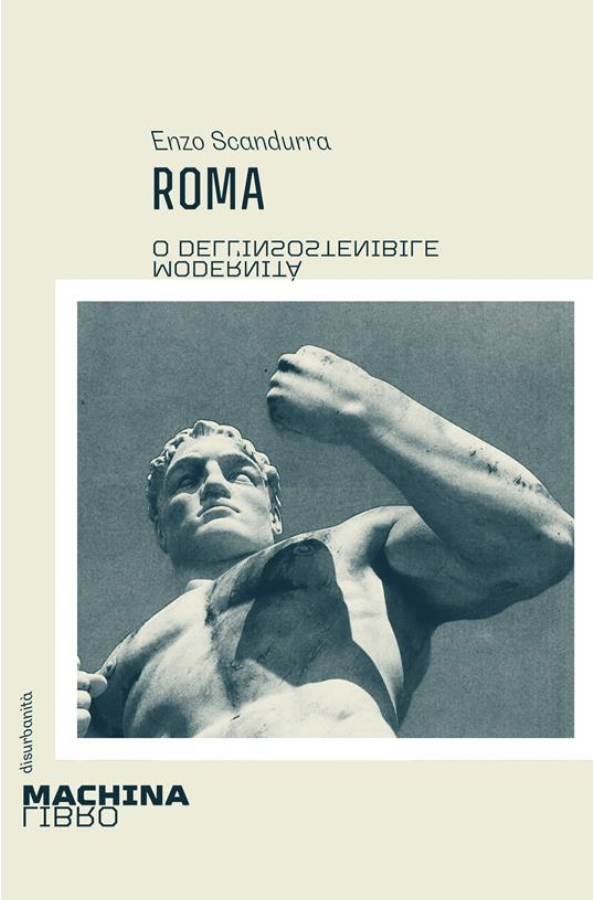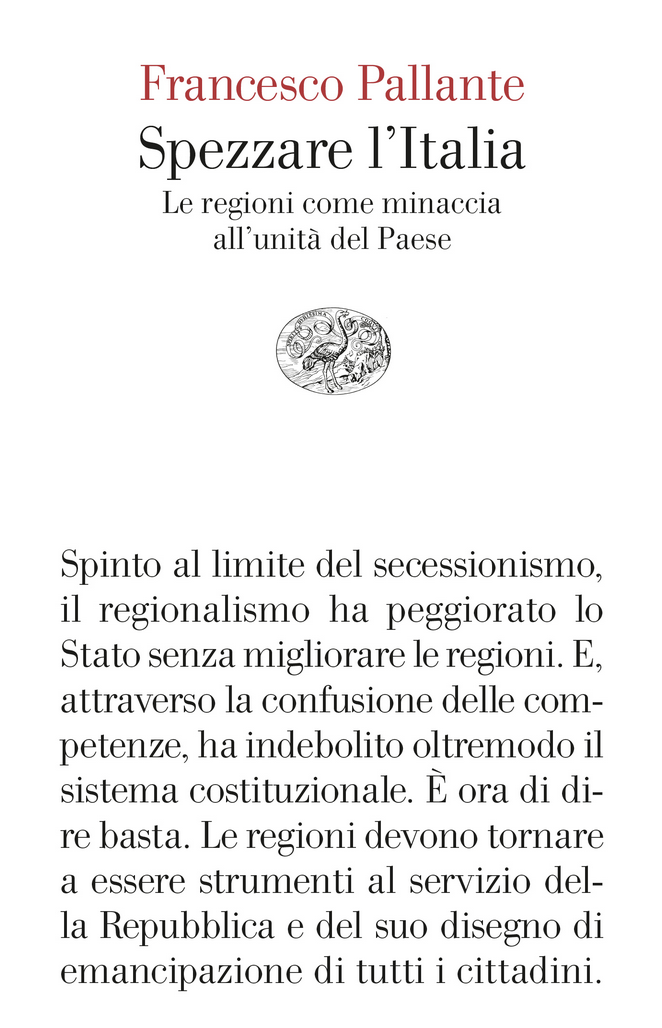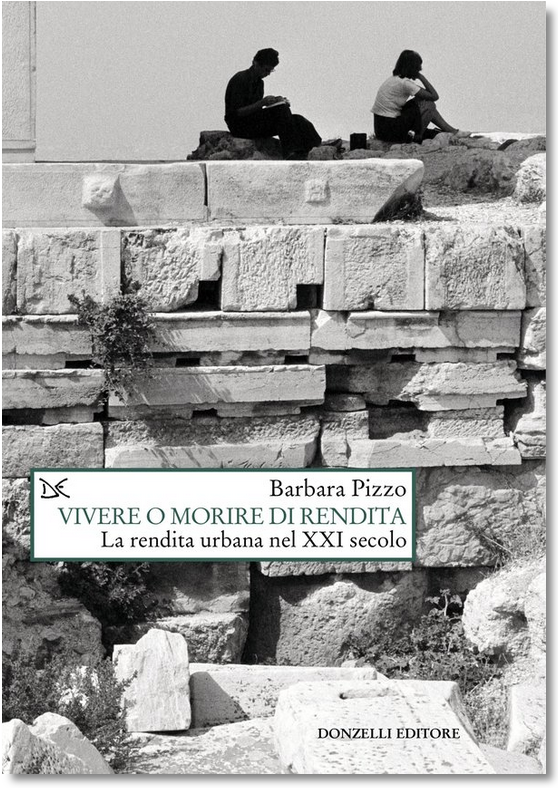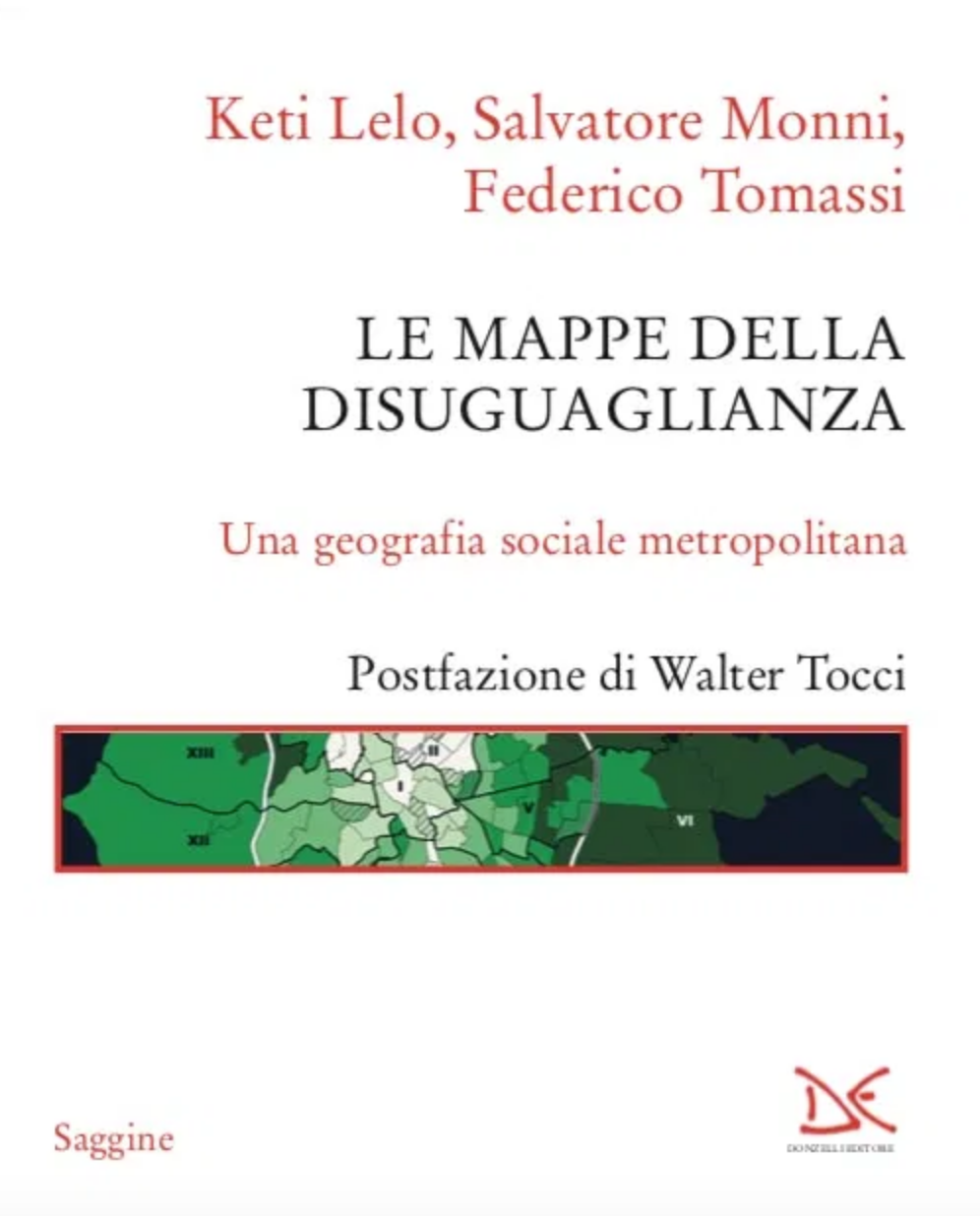- Home
- Chi siamo
- Chi siamo – il laboratorio
- Iscriviti alla newsletter
- Il Manifesto di Carteinregola
- Le nostre regole
- Rete di Carteinregola
- Le iniziative di Carteinregola dal dicembre 2020
- Tutte le nostre iniziative
- Fatti sentire! Impariamo a usare gli strumenti di comunicazione
- Censimento
- Piediperterra
- Piediperterra a Dragona e Dragoncello
- 1. Parco del Drago: appunti per una introduzione storica
- 2. Dragoncello: storia del Parco del Drago, Convenzione urbanistica PRU e progetti
- 3. Storia di Dragona
- 4. Dragona: il Museo D. Agostinelli
- 5. Dragona: il Punto Verde Qualità
- 6. Dragona: La stazione Acilia sud Dragona
- 7. Dragona – Dragoncello: Dorsale mare Tevere
- 8. Progetto Casale Dragoncello
- Piediperterra a San Lorenzo – Municipio II Roma
- Piediperterra a Testaccio
- Piediperterra a Casal Bertone – 5 luglio 2018
- Piediperterra 1
- Piediperterra 2 a Morena
- Spiazmoli! Piediperterra all’EUR 3- Spiazziamoli! IL PERCORSO
- Piedi per terra al Torrino sud il 20 gennaio 2017
- Piediperterra a Primavalle -28 aprile 2018
- Piediperterra a Dragona e Dragoncello
- Diario Presidio Campidoglio 2012-2013
- Dieci parole dell’ urbanistica
- Rassegna stampa
- Laboratorio
- La Mappa
- Calendario
- Istituzioni
- ISTITUZIONI
- Governo Italiano
- ROMA CAPITALE
- La consiliatura Gualtieri dal 2021
- Deliberazioni dell’Assemblea Capitolina dal 2021
- Deliberazioni della Giunta Gualtieri dal 2021
- Roberto Gualtieri Sindaco
- La Giunta Capitolina Gualtieri 2021
- Silvia Scozzese Vicesindaco e Assessore al Bilancio
- Sabrina Alfonsi, Assessore ai Rifiuti, Ambiente e Agricoltura
- Andrea Catarci Assessore al decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti
- Barbara Funari, Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute.
- Miguel Gotor, Assessore alla cultura
- Monica Lucarelli Assessore alle Attività produttive e Pari opportunità
- Alessandro Onorato Assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport
- Eugenio Patanè Assessore ai Trasporti
- Claudia Pratelli Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro
- Ornella Segnalini Assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture
- Tobia Zevi Assessore al Patrimonio e Politiche abitative
- Maurizio Veloccia – Assessore all’Urbanistica
- Assemblea Capitolina 2021
- Presidenti, Giunte, Consiglieri Municipi dal 2021
- Roma Capitale e CittàMetropolitana
- Le aziende partecipate del Comune di Roma
- Comune di Roma leggi norme e regolamenti
- La consiliatura Gualtieri dal 2021
- Elezioni a Roma
- Regione Lazio
- ISTITUZIONI
- PoliticaLab
- iDOSSIER
- Autonomia Regionale Differenziata, cronologia e materiali
- Modifiche al PRG di Roma
- PianoCasa/Legge rigenerazione urbana Lazio
- Progetto Porto turistico – crocieristico di Fiumicino – cronologia e materiali
- Affittacamere, case per vacanze, B&B a Roma e nel Lazio – cronologia e materiali
- Lago ex SNIA Viscosa – V Municipio
- Ex clinica Villa Bianca Cronologia
- Stadio Flaminio – II Municipio cronologia
- Circolo Poste e sotto ponte della Musica – cronologia e materiali
- Lago e area ex SNIA Viscosa – V municipio
- Regolamento del Verde di Roma
- PTPR – Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (del Lazio)
- PatrimonioComune cronologia materiali
- PUP Piano Urbano Parcheggi cronologia materiali
- ProgettoFlaminio
- DecretoTrasparenza
- V.I.A. Valutazione Impatto Ambientale
- Stadio Tor di valle cronologia
- Pineta di Villa Massimo (Punto Verde Infanzia) II Municipio
- Il Parco di Centocelle – V Municipio – cronologia e materiali
- Pianidizona
- PVQ
- MetroC
- Torri dell’EUR
- ForteTrionfale
- Autorecupero a scopo abitativo del patrimonio pubblico esistente – cronologia e materiali
- ATAC – cronologia e materiali
- BastaCartelloni
- iQuaderni
- Stadio Pietralata
- Modifiche al PRG
- Regolamento del Verde
- L’Italia non si taglia
- Giubileo 2025
- Urbanistica del Lazio 2023-24
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 1 (governo del territorio- interventi in zona agricola)
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 2 (rigenerazione urbana)
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 6 (valorizzazione degli immobili di proprietà pubblica)
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 7 (procedure di Valutazione Ambientale)
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 10 (strumenti attuativi)
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 13
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 15 (attività estrattive)
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 16 (aree sviluppo industriale)
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 17 (edilizia agevolata)
canlı casino siteleri online casino rottbet giriş rott bet güncel giriş
Widgetized Section
Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone
Filippo Grandi: Esodi forzati oggi: una questione di umanità
Pubblichiamo il video e il testo della conferenza di Filippo Grandi, Alto commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr),«Esodi forzati oggi: una questione di umanità» tenuto il 22 marzo 2019 all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, alla prima edizione della Martini Lecture Bicocca, proposta dal Centro pastorale “C.M. Martini” in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e la Fondazione Carlo Maria Martini, e patrocinata dalla Diocesi di Milano.(da https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/accoglienza-dalle-parole-di-martini-luce-anche-oggi-261939.html)
Omessa introduzione : scarica il PDF con l’I 
(…)
Si parla, oggi, e sempre più spesso, di “crisi” dei rifugiati. È vero che il numero di persone sradicate dalla propria terra da conflitti, violenze e persecuzioni è in crescita. Il numero totale delle persone costrette a fuggire a causa di guerre, violenze, persecuzioni e malgoverno, fuori e dentro ai confini dei propri paesi, ha superato per la prima volta i 70 milioni, di cui circa 25 milioni possono essere considerati rifugiati a tutti gli effetti, avendo traversato una frontiera, e a volte diverse frontiere, in cerca di quella che chiamiamo protezione internazionale – un numero raddoppiato rispetto a qualche anno fa. Questi movimenti hanno avuto conseguenze globali, certo, ma l’impatto più profondo e immediato si è prodotto sui paesi in via di sviluppo, dove sono accolti più di otto rifugiati su dieci, o su quegli Stati fragilissimi che sono teatro dei conflitti che provocano lo sfollamento di decine di milioni di persone all’interno dei propri confini.
Invece la percezione prevalente è che la “crisi” dei rifugiati affligga soprattutto i paesi ricchi. È una percezione alimentata dalla retorica politica, quella – per intenderci – dell’ “invasione”, che continua a trovare sostenitori, che
poggia su un nodo complesso di paure abilmente manipolate e pregiudizi coltivati ad arte, e che (come abbiamo visto solo qualche giorno fa in Nuova Zelanda) può giungere a conseguenze terrificanti. La realtà è ben diversa, ed è questo il primo messaggio che vorrei trasmettere oggi. È nei paesi resi fragili da guerre e violenza, nelle comunità di frontiera, nelle periferie e spesso nelle zone più povere dei paesi e delle regioni prossimi alle aree di conflitto che la “crisi” dei rifugiati è acuta e drammatica.
Prendiamo la situazione del Bangladesh, dove negli ultimi quattro mesi del 2017 sono arrivate oltre 650.000 persone di etnia Rohingya, attraversando il confine del Myanmar: traumatizzate, esauste e disperate, in fuga da una brutale operazione militare durante la quale migliaia di membri della loro comunità sono stati uccisi e le loro case e villaggi distrutti.
Ho visitato la regione di Cox’s Bazar – una delle più povere del Bangladesh – poche settimane dopo l’inizio della crisi. I rifugiati erano ammassati a migliaia in alloggi improvvisati ai bordi delle strade, nelle foreste, a ridosso delle colline, mescolati ai loro compatrioti che già si trovavano in quella regione, frutto di esodi precedenti: quasi un milione di persone in una delle zone geograficamente ed economicamente più svantaggiate del paese.
In mezzo a quella terribile, disperata miseria, nel caos dell’emergenza, la popolazione locale si era organizzata per aiutare i rifugiati: un’operazione umanitaria disordinata e spontanea, ma efficace e addirittura indispensabile a salvare vite in pericolo e dare un po’ di conforto; mentre il governo del Bangladesh, mantenendo aperte le frontiere per tutta la durata della crisi,assicurava un rifugio relativamente sicuro ai fuggiaschi e dava spazio a quella prima risposta d’emergenza.
La crisi dei Rohingya – strappati alla propria terra da violenze e persecuzioni, dopo decenni di esclusione, discriminazione e ripetute fughe – costituisce un esempio crudo e illuminante di molte delle emergenze su larga scala che oggi provocano movimenti di massa di rifugiati in paesi con risorse limitate. Esemplifica chiaramente come le conseguenze di queste crisi abbiano l’impatto più forte nel sud del mondo. Ma illustra anche un fenomeno sorprendente: sono spesso le comunità di quegli stessi paesi le prime a condividere alloggio, terra, cibo e acqua con le persone in fuga. Non è retorica, l’ho visto in molti paesi, non solo in Bangladesh ma in centinaia di villaggi africani, alle frontiere di paesi martoriati dalla guerra come la Siria, negli stati del Sudamerica alle cui porte bussano milioni di venezuelani in fuga dal collasso di infrastrutture, economia e istituzioni. E quasi sempre questa risposta solidale non diventa – come purtroppo troppo spesso accade oggi in Europa – oggetto di negoziati politici e manipolazioni mediatiche, ma esprime con spontaneità i valori propri a tradizioni, culture e società diverse ma tutte ugualmente aperte al concetto profondo di “asilo””. In altre parole, testimonia di un imperativo umanitario che è condiviso nelle principali tradizioni culturali e religiose, e si rispecchia nel diritto internazionale.
In Siria, otto anni di devastante conflitto hanno costretto alla fuga quasi metà della popolazione pre-bellica – compresi cinque milioni di rifugiati nei paesi vicini e un altro milione emigrato in Europa e altrove. Per la stragrande maggioranza dei rifugiati siriani accolti nei paesi della regione – Turchia, Libano, Giordania, Iraq ed Egitto – la vita resta una battaglia quotidiana, così come per le comunità urbane che li accolgono, sostenendo sforzi immani.
Anche qui, la generosità e l’ospitalità delle comunità di accoglienza sono notevoli, come ho potuto constatare una volta di più in Libano solo qualche giorno fa. Giocano un ruolo importante i legami sociali e familiari e una forte tradizione di ospitalità locale plasmata da una storia multiculturale segnata dalla diversità. Le sfide, però, sono molte e si stanno aggravando: la storia del Libano è anche costellata di fratture; le complesse dinamiche politiche regionali e locali, e l’impatto sociale, economico e politico del vicinissimo conflitto siriano sono significativi, e molti rifugiati devono far fronte a ostilità e discriminazioni. Anche in Giordania, un paese che negli ultimi 70 anni ha accolto ondate successive di rifugiati palestinesi, iracheni e ora siriani, i crescenti problemi economici rendono quell’accoglienza più difficile e controversa.
Un terzo esempio è quello della Colombia, un paese che sta provando a uscire da decenni di conflitto civile, e che ora fatica a gestire il flusso massiccio di persone dal Venezuela – flusso che è andato crescendo negli ultimi mesi lungo i duemila chilometri di confine fra i due paesi. Nelle zone in cui la pace è più fragile, le comunità locali condividono lo scarso cibo e gli spazi ridotti a loro disposizione con i nuovi arrivati, che perlopiù arrivano in condizioni di trauma e indigenza. Ricordo per esempio una comunità di sfollati colombiani vicino a Cúcuta – esiliata all’interno del proprio paese dal lungo conflitto tra governo e gruppi armati – che ci ha spiegato come si era organizzata per condividere le sue scarse risorse con i venezuelani in arrivo attraverso la vicina frontiera. E con piùdi tre milioni e mezzo di persone in fuga dal Venezuela, l’impatto della crisi si è ormai esteso all’intera regione.
E diamo uno sguardo anche all’Etiopia – che continua ad accogliere quasi un milione di rifugiati in fuga da alcuni degli stati confinanti – Eritrea, Somalia, Sudan e Sud Sudan – e che negli ultimi anni è diventato paese-simbolo della messa in atto dei valori di solidarietà, protezione e inclusione dei rifugiati. Ma il prezzo è altissimo. Nella sola regione di Gambella vivono oltre 400.000 rifugiati del Sud Sudan, strappati alle proprie case dal conflitto devastante che ha costretto alla fuga oltre un terzo della popolazione del loro paese. Sono più numerosi della popolazione locale. Tuttavia, nel gennaio scorso, l’Etiopia ha adottato una storica nuova legge sui rifugiati che allarga l’accesso all’istruzione, al mercato del lavoro, alla registrazione legale di documenti. Non è stato un processo privo di controversie – come in altre parti del mondo, la presenza di rifugiati ha innescato un numero crescente di complessi dibattiti politici. Ma un’analisi scrupolosa e una leadership politica coraggiosa stanno contribuendo a definire in Etiopia un nuovo approccio alla questione dell’accoglienza in Africa: un esempio importante per tutto il continente e per il mondo intero.
Questi quattro esempi, relativi a contesti diversi, illustrano l’impatto profondo delle crisi migratorie sulle comunità di paesi che dispongono di risorse limitate ma che accolgono la stragrande maggioranza dei rifugiati del mondo con compassione e umanità.
***
L’impatto su chi si trova in esilio è durissimo. Ogni giorno, nel mondo, sono milioni a dover compiere scelte impossibili. Mettetevi nei loro panni. Tornare a casa, in situazioni fragili e pericolose? Restare dove si trovano, arrancando ai margini della società, spesso senza uno status giuridico sicuro, nella povertà più insopportabile? Intraprendere viaggi pericolosi verso altri paesi, mettendo a rischio le proprie vite nella ricerca (senza certezze) di maggiore sicurezza, di protezione, di un futuro stabile? Per alcuni, questa opzione – rimettersi in viaggio – può apparire l’unica soluzione, in particolare in situazioni in cui il sostegno internazionale ai paesi di accoglienza è insufficiente o i diritti dei rifugiati sono limitati. E per i rifugiati che fanno questa scelta comincia quasi sempre un’esperienza condivisa con quella dei migranti, che hanno lasciato i propri paesi per altre ragioni.
È importante ricordare che la stragrande maggioranza di questi ultimi viaggia tramite canali regolari; i loro movimenti dipendono dalle politiche e pratiche migratorie e dalla domanda di lavoro dei paesi di destinazione. Gli squilibri demografici e il divario economico tra paesi ricchi e poveri, però, uniti a una gestione sempre più inadeguata delle migrazioni e all’insufficienza di canali migratori legali, risultano in un numero crescente di migranti che decidono invece di intraprendere il proprio viaggio attraverso rotte illegali, in condizioni difficili e disperate. Queste sono le stesse rotte intraprese molto spesso dai rifugiati, che fuggono non per scelta ma per mancanza di scelte. Entrambi – rifugiati e migranti irregolari – si trovano così quasi sempre esposti insieme a sfruttamento e abusi da parte di coloro i quali, di queste rotte, hanno fatto un’immensa, ramificata impresa criminale internazionale.Il fenomeno dei flussi “misti” non è certo nuovo ma è in aumento, e ci pone davanti a sfide sempre più complicate. Le circostanze che spingono tutte queste persone a lasciare i propri paesi spesso si sovrappongono: malgoverno, povertà e profonde disuguaglianze, degrado ambientale, assenza di risorse, carenza di acqua e insicurezza alimentare, effetti del cambiamento climatico fanno quasi sempre parte degli stessi contesti su cui si innestano guerre e violenza.
Ed i rischi gravissimi, spesso fatali, a cui rifugiati e migranti sono esposti sono molto simili. Entrambi i gruppi includono poi individui particolarmente vulnerabili, quali minori separati dalle loro famiglie o non accompagnati, donne vittime di tratta e violenza, persone anziane o ammalate.
Ciò detto, la mia organizzazione, l’UNHCR, ritiene che sia importante mantenere la distinzione tra i due gruppi, per meglio difendere i diritti specifici di entrambi. I rifugiati – indipendentemente da dove si trovano o dalle modalità di viaggio – godono anche di una serie di diritti in conformità al diritto internazionale, giustificati dall’impossibilità di poter fare ritorno nei propri paesi di origine senza che la loro vita sia messa in pericolo. La gestione delle migrazioni internazionali invece è regolata da una serie differente di accordi, compresi quelli che prevedono il rimpatrio dei richiedenti asilo la cui domanda non è stata accolta.
La risposta ai flussi migratori misti, pertanto, richiede un approccio coerente, ma differenziato, che assicuri che i rifugiati siano protetti, tutelando, allo stesso tempo, la dignità e i diritti di tutte le persone in movimento,specialmente quelle più vulnerabili. È un’operazione complessa, ma possibile. Proteggere i rifugiati, e trovare soluzioni per i migranti, è tra l’altro pienamente compatibile con una gestione efficace delle frontiere, che richiede però una stretta cooperazione fra Stati – a livello tanto regionale quanto internazionale – data la natura transnazionale dei flussi misti.
Ed è proprio l’insufficienza di questa cooperazione – specialmente in Europa – che ha trasformato in “crisi” un fenomeno serio e complesso, ma fondamentalmente gestibile.
Tra gli elementi fondanti dell’identità europea del dopoguerra – soprattutto dell’Unione Europea – c’è senz’altro anche l’impegno a essere un continente di accoglienza e rifugio. Nei decenni seguiti alla Seconda Guerra Mondiale l’Europa ha sviluppato un sistema di asilo solido e relativamente efficace. Gli esodi provocati dalle guerre nei Balcani, negli anni Novanta, hanno messo alla prova il sistema di accoglienza, ma – lavorando tra loro e rispettando i principi di base – gli Stati europei hanno saputo gestire quella crisi.
Una serie di fattori ha cambiato gli scenari negli anni successivi: i flussi misti, soprattutto dall’Africa, di cui ho parlato; lo sviluppo del traffico di esseri umani; la crisi finanziaria ed economica globale; la crescita del fenomeno terroristico; e finalmente la guerra in Siria, che ha causato un esodo immenso alle porte dell’Europa. Il sistema internazionale si è presto rivelato incapace di risolvere il conflitto siriano; milioni di cittadini siriani hanno capito rapidamente che la guerra sarebbe durata a lungo, e milioni di rifugiati siriani nei paesi confinanti hanno compreso che gli aiuti sarebbero rimasti scarsi e insufficienti, soprattutto in settori importanti come l’educazione e il lavoro; il business dei traffici ha fiutato l’affare: e centinaia di migliaia di persone – dalla Siria e dai paesi vicini ma anche da un vasto bacino di altri paesi d’origine – hanno preso la via dell’Europa tra il 2015 e il 2016. Il sistema di accoglienza europeo non ha retto. Politici senza scrupoli hanno gridato all’invasione, altri – con rare eccezioni – hanno avuto paura a seguire la cancelliera Merkel nel suo coraggioso tentativo di promuovere un approccio insieme solidale e meglio organizzato. La cooperazione inter-europea si è frantumata.
L’impressione di caos che ne è conseguita ha avuto effetti letali, offrendo uno sbocco concreto a una complessa rete di paure e pregiudizi diffusi e fino ad allora relativamente latenti nelle società europee, e un argomento vincente a coloro che hanno compreso il capitale di voti e consenso che la stigmatizzazione di rifugiati e migranti portava con sé.
Le apprensioni che sono state sfruttate da questa abile manipolazione globale non vanno, naturalmente, sottovalutate. Sono reali e sono giustificate. Milioni di persone, soprattutto nei paesi industrializzati, si sentono abbandonate a causa della globalizzazione, frustrate dall’insicurezza economica e dalle crescenti disuguaglianze che le fanno da contorno. Chi è stato alla guida di quelle stesse società negli ultimi decenni – nelle sfere della politica, dell’economia, della cultura – non ha capito o non ha risposto in tempo. Le frustrazioni sono esplose, specialmente con la crisi finanziaria del 2008. L’arrivo massiccio di rifugiati e migranti in Europa negli anni successivi e soprattutto nel 2015 ha offerto un bersaglio ideale sul quale riversare quelle frustrazioni e quei timori.
Il risultato, in Europa e anche in Italia, è una società che non è mai stata tanto frammentata e divisa dal dopoguerra a oggi. Rifugiati e migranti sono divenuti uno dei punti di rottura attorno al quale paure e incertezze si sono cristallizzate, agitate da politici irresponsabili – forse il punto di rottura più difficile, più grave, più discusso. In tale contesto, la narrativa prevalente è quella dei politici con meno scrupoli: rigetto ed esclusione, e basta. È una proposta che non ha fondamento e non risolve nulla, ma che ha il vantaggio della semplicità di fronte a questioni che invece necessitano risposte complesse. E dunque crea consenso.
La realtà naturalmente è diversa. Innanzitutto il concetto di “crisi” va sfatato. È difficile dirlo, ma va detto: non c’è “crisi” migratoria in Europa! Il numero di persone in arrivo sulle coste europee attraverso il Mediterraneo è calato ai livelli più bassi degli ultimi cinque anni. La responsabilità di accogliere rifugiati e migranti continua però a ricadere in modo sproporzionato su un numero ridotto di Stati, dettato in larga parte dalla geografia: Italia, Grecia, Malta e Spagna. Quella di oggi in Europa non dunque è una crisi di numeri, ma semmai di solidarietà.
Ciò che invece preoccupa è che il tasso di morti in mare sia cresciuto parallelamente alle restrizioni poste alle operazioni di soccorso, soprattutto quelle condotte dalle ONG. Nel 2018, sei persone al giorno sono morte nel Mediterraneo – una vergogna insanabile per il nostro continente. Il soccorso in mare e il diritto di richiedere asilo in Europa devono esseri preservati. In occasione di arrivi recenti, sono stati raggiunti accordi per la distribuzione in vari Stati europei delle persone che si trovavano a bordo. Questo è positivo, ma non può continuare a essere negoziato ogni volta che un’imbarcazione si avvicina alle coste europee.
Insieme all’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, l’UNHCR ha presentato una serie di proposte all’Unione Europea per l’adozione di misure efficaci e praticabili che permettano agli Stati di condividere in maniera prevedibile le responsabilità legate allo sbarco di rifugiati e migranti. Queste proposte riguardano le condizioni di accoglienza, il sostegno ai più vulnerabili, procedure di registrazione e controllo più rapide ed efficaci, e una gestione più efficace delle decisioni relative alle domande d’asilo. Lo scopo è quello di assicurare che le persone che necessitano di protezione internazionale siano identificate rapidamente e ricevano l’aiuto di cui hanno bisogno; e che i migranti irregolari che non possono soggiornare legalmente siano trattati in modo adeguato e umano.
I flussi verso l’Europa (così come in altre parte del mondo, in America Centrale verso gli Stati Uniti, per esempio) vanno però visti e gestiti in prospettive più ampie. A “valle”, per così dire, è necessario e urgente che il sistema d’asilo europeo sia riformato – il meccanismo di Dublino chiaramente non è più adeguato alla situazione attuale. Ma è a “monte” che la risposta deve diventare molto più lungimirante e strategica. Le persone in movimento attraversano una serie di paesi per poter giungere in Europa. Il più problematico è certamente la Libia, lacerato da un conflitto complesso. Qui una popolazione di rifugiati e migranti vive in condizioni terribili, molti dei quali in centri di detenzione che sono tra i luoghi più spaventosi che ho visto nella mia pur lunga carriera umanitaria.
Il conflitto libico è estremamente complicato. È chiaro però che l’Europa e anche l’Italia negli ultimi due o tre anni hanno dato priorità soprattutto alla questione degli sbarchi, scegliendo di rinforzare l’azione della guardia costiera libica per limitare le traversate – oggi l’85% di coloro che cercano di lasciare la Libia su imbarcazioni irregolari viene intercettato e riportato a terra. E siccome a terra il conflitto continua, e nessuna altra istituzione libica funziona come la guardia costiera, il destino di quelli che vengono riportati in Libia è di essere nuovamente esposti ad abusi, sfruttamento, tortura e violenze.
L’UNHCR e l’OIM sono presenti in Libia. Da più di un anno abbiamo moltiplicato gli sforzi per aiutare – nei limiti del possibile – migliaia di rifugiati e migranti bloccati nel paese: aiuti umanitari (là dove possiamo arrivare), negoziati con autorità e gruppi armati per farli uscire da quei centri di detenzione a cui abbiamo accesso, rimpatrio volontario dei migranti che decidono di tornare a casa, evacuazione verso paesi terzi dei rifugiati che a casa non possono tornare. Sono sforzi immani, costosi, portati avanti in condizioni di pericolo grave e continuo, criticati da chi vorrebbe che facessimo di più, stigmatizzati da chi sostiene che avalliamo un sistema di sfruttamento, avversati dalle milizie armate che controllano gran parte della Libia e traggono vantaggio economico dal traffico delle persone. Ma sono sforzi necessari e li continueremo. Più di 37mila migranti hanno fatto ritorno nei propri paesi grazie all’OIM. Attraverso il programma di evacuazione d’emergenza dell’UNHCR più di tremila rifugiati a rischio sono stati trasportati direttamente in Europa – soprattutto in Italia – oppure in Niger, per essere poi trasferiti in altri paesi.
Certo, si tratta di gocce nel mare rispetto alla vastità e gravità del problema, le cui reali dimensioni nessuno conosce veramente. Ed è importante che nessuno strumentalizzi la nostra presenza in Libia per esonerare l’Europa dall’accoglienza di coloro che arrivano nel continente, e soprattutto per non agire – di concerto, strategicamente – per trovare d’urgenza una soluzione politica al conflitto libico.
Ma dobbiamo guardare anche al di là della Libia, ancora più a “monte”. L’Europa investe molte risorse nelle operazioni umanitarie e nello sviluppo economico in Africa e in Medio Oriente. È chiaro però queste risorse non sono indirizzate strategicamente, e non sono sufficienti ad affrontare le cause profonde dei movimenti irregolari, soprattutto povertà e questioni climatiche; e dall’altro per partecipare in modo più coerente e concertato alla risoluzione politica dei conflitti che causano movimenti di rifugiati. Nel frattempo, è anche necessario stanziare più aiuti, e a più lungo termine, in appoggio ai paesi che ospitano – come ho detto – la grande maggioranza dei rifugiati nel mondo, per evitare che i rifugiati stessi intraprendano viaggi pericolosi e spesso non necessari. Ricordo che le nostre operazioni nei grandi paesi d’asilo africani, per esempio, restano tra le più difficili da finanziare. L’argomento che gli aiuti sono già ingenti e hanno raggiunto il massimo del loro volume – un argomento frequente tra i paesi donatori – non è solamente discutibile; è anche strategicamente sbagliato. Senza una maggiore condivisione di risorse le disuguaglianze tra paesi e società aumenterà, rendendo i movimenti di popolazione sempre più ardui da gestire.
Anche i programmi cosiddetti di reinsediamento – tramite quelli che in Italia vengono oggi chiamati “corridoi umanitari” e altri canali – devono essere potenziati. Nell’ottobre del 2017 ho chiesto la disponibilità di 40.000 posti per il reinsediamento di rifugiati da 15 paesi di asilo o transito lungo le rotte che portano al Mediterraneo centrale e occidentale. Abbiamo ottenuto la disponibilità di oltre 39.000 posti, compresi circa 14.000 assicurati da Stati membri dell’Unione Europea. Dunque è possibile – ma non deve esserlo solo quando la pressione degli arrivi aumenta. È uno sforzo che va sostenuto, perché serve da valvola di sicurezza particolarmente per i rifugiati più a rischio, per i quali le garanzie di protezione in molti dei paesi vicini ai conflitti non sono sufficienti.
***
Vi ho parlato delle crisi, quelle vere. Ho cercato di spiegarvi quali sono le cose che secondo noi vanno fatte per affrontare i fenomeni dei flussi migratori. È un contesto difficile, non lo nego. Forse mai, nella storia quasi settantennale della mia organizzazione, ci siamo trovati di fronte a sfide così complicate, soprattutto nella sfera politica.
Ma prima di terminare vorrei condividere ancora qualche pensiero più ampio – sulla resilienza della solidarietà, e su come trasferirla sul piano istituzionale per renderla più universale ed efficace insieme.
La convinzione che proteggere chi è perseguitato e aiutare quanti sono stati sradicati dalla propria terra faccia parte dei fondamenti morali delle società, e che questi fondamenti richiedano di agire e cooperare con spirito umanitario ed efficacia al tempo stesso, esiste ancora.
Negli ultimi anni, in mezzo al frastuono a volte assordante del linguaggio ostile di certa politica, abbiamo continuato ad assistere a gesti forti di solidarietà in molti paesi, inclusa l’Italia – da parte della società civile, di associazioni, di rappresentanti religiosi, del mondo dell’imprenditoria e della scuola, di figure eminenti dello sport e della cultura. Molte, moltissime persone – certo più di quanto si sappia – hanno contribuito ad accogliere i rifugiati e ad aiutarli a integrarsi. E forse ancora più importante, c’è consapevolezza che rifugiati e migranti sono anche e soprattutto persone che danno contributi importanti alla nostra società, ammesso che la loro integrazione (un tema che meriterebbe una discussione separata, ma che naturalmente è fondamentale) venga incoraggiata e sostenuta come un’ “occasione provvidenziale” di arricchimento nella diversità, per citare il cardinale Martini.
Gli esempi sono tanti.
Come la comunità di Torre Melissa in Calabria che, coraggiosamente, ha salvato strappandoli al mare un gruppo di 50 rifugiati e migranti naufragati dopo che la loro imbarcazione si era capovolta, a gennaio.
Come le migliaia di persone che si sono messe a disposizione per diventare tutori di minori non accompagnati e separati.
Come le dozzine di famiglie che hanno aperto le proprie case ai rifugiati attraverso il programma “Refugees Welcome Italia”.
Come i ragazzi e le ragazze delle scuole secondarie di tutto il paese che dedicano volontariamente quattro ore ogni settimana per insegnare l’italiano ai rifugiati.
Come le aziende italiane – e sono sempre più numerose – che assumono rifugiati e sostengono la loro integrazione, facendo il possibile per prevenire e combattere xenofobia e razzismo.
Come tutte quelle città che si sono poste alla testa della solidarietà organizzata – innovando l’accoglienza, nell’ambito di identità civiche forti ma aperte; ricorrendo alla loro esperienza pratica nella fornitura dei servizi; facendosi carico delle vulnerabilità; coordinando le diverse componenti delle comunità cittadine.
Una ricerca pubblicata alla fine dell’anno scorso riporta che oltre sette italiani su dieci sostengono il diritto di asilo e ritengono che alle persone dovrebbe essere permesso di cercare rifugio in altri paesi, fra i quali l’Italia. I valori di ospitalità, accoglienza e solidarietà verso chi ne ha bisogno costituiscono una parte fondamentale dell’identità civica italiana, anche fra coloro che esprimono apprensione rispetto all’impatto delle migrazioni.
L’Italia è, e resta, un paese solidale.
In parallelo però, e non mi stanco di dirlo, è essenziale che la fiducia nei sistemi che governano l’asilo e le migrazioni sia ripristinata, attraverso una gestione migliore e più efficiente dell’accoglienza, e attraverso la cooperazione con altri governi europei. Limitare l’accesso all’assistenza, e cancellare la protezione umanitaria, sono misure che non risolvono e che anzi complicano, perché estromettono le persone dalle strutture di accoglienza costringendole a vivere ai margini, là dove i rischi – per loro e per il resto della società – sono maggiori.
Da un lato, dunque, la società civile e le istituzioni locali svolgono un ruolo importantissimo nel preservare l’accoglienza e difendere la solidarietà; dall’altro, assistiamo a una crisi di fiducia nel sistema che gestisce flussi sempre più complessi.
È una situazione alla quale, con alcune variazioni, assistiamo in molti paesi europei e anche altrove nel mondo.
Per questi motivi, nel 2016, l’anno dopo l’arrivo dell’ondata di rifugiati e migranti in Europa, gli Stati si sono riuniti a New York per decidere come rispondere a questi fenomeni.
Il risultato di quelle deliberazioni, sancito da una risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è stata l’elaborazione di due “compact” o patti globali – uno sui rifugiati, e un altro sulle migrazioni. Entrambi sono stati adottati dalle Nazioni Unite lo scorso dicembre. Di questi patti si è molto parlato – a proposito e a sproposito.
Il patto sui rifugiati ribadisce la Convenzione del 1951 in quanto strumento fondamentale di protezione dei rifugiati – documento che riflette valori universali e condivisi, e allo stesso tempo strumento pragmatico ed efficace di risposta ai flussi migratori che rispecchia tanto gli interessi dei rifugiati, quanto quelli dei governi e delle persone che li accolgono. Il patto non è vincolante ma indica e spiega una serie di misure volte soprattutto ad appoggiare i governi che accolgono il maggior numero di rifugiati nello sviluppare politiche aperte e inclusive nei loro confronti. La tela di fondo, per così dire, è il principio che dei rifugiati sono responsabili tutti i paesi, e non solo quelli vicini alle crisi. E il patto suggerisce anche una serie di misure pratiche per realizzare in modo concreto questa responsabilità collettiva, ciascuno secondo i suoi mezzi e le sue capacità.
Il patto propone che le risposte alle crisi di rifugiati vadano oltre gli schemi tradizionali dell’assistenza umanitaria fornita da alcuni Stati attraverso il sistema ONU e un numero limitato di ONG, e promuove un concetto più ampio nel quale giocano un ruolo molto importante le organizzazioni di sviluppo sociale ed economico, come la Banca Mondiale; il settore privato; le istituzioni locali; e la società civile in tutte le sue componenti, incluso il mondo universitario. Abbiamo cominciato a sperimentare questo approccio in 15 paesi dell’Africa e dell’America Latina, con risultati incoraggianti. In questo senso il patto mira a riunire la solidarietà spontanea della società civile con quella organizzata degli Stati, ricreando un clima di fiducia attorno a questa problematica così difficile: rispondere alle crisi dei rifugiati è alla nostra portata; trovare soluzioni è possibile.
Il patto mondiale sui rifugiati è stato sviluppato parallelamente a un secondo patto, che promuove invece un concetto di migrazioni meglio gestite – sicure, ordinate e regolari. È chiaro da quello che ho detto poco fa che i due patti – in un mondo di flussi sempre più “misti” – sono distinti ma anche complementari. Per questo, mentre mi felicito per l’adesione e il forte sostegno dell’Italia al patto sui rifugiati, mi dispiace che lo stesso non sia accaduto per quello sulle migrazioni. Questo, dal mio punto di vista, è stato un errore. Pochi paesi più dell’Italia possono trarre beneficio da un rafforzamento della cooperazione internazionale in questo campo.
***
Vorrei concludere ritornando a Milano e al cardinale Martini.
La tematica dei movimenti di popolazione, della gestione dei flussi, dell’accoglienza e dell’integrazione è estremamente complessa e difficile. Ho cercato di spiegarne alcuni aspetti, sottolineando come non sia impossibile affrontarli e anche risolverli. Spero di avere anche illustrato come per riuscire a farlo, bisogna unire posizioni forti – la solidarietà, l’apertura al dialogo, in altre parole l’umanità – a misure concrete, bene organizzate, e frutto di cooperazione internazionale.
Nella Milano che lasciai più di trent’anni fa per andare a fare il volontario alla frontiera tra Thailandia e Cambogia era arcivescovo Carlo Maria Martini, un uomo le cui posizioni, già allora, erano di ispirazione a chi di noi cercava orizzonti ampi, diversi, di confronto e scambio. Erano – appunto – posizioni forti, ma che sempre, nel suo linguaggio così chiaro, univano l’ideale al pratico. Anche in questo connubio, così milanese ma così significativo nel quadro più ampio del suo insegnamento pastorale e spirituale, Martini faceva luce.
Il 6 dicembre di trent’anni fa, alla vigilia di Sant’Ambrogio, la festa di Milano, il cardinale pronunciò un discorso importante. Erano giorni di trepidazione e speranza. La cortina di ferro che aveva spezzato in due l’Europa per decenni stava crollando. L’arcivescovo, esortando Milano a essere “luogo di accoglienza e segno di unità”, citava proprio un passo di Ambrogio, tratto dal libro “Sui doveri”:
“Quelli che escludono i forestieri dalla città non meritano certo approvazione, Ciò significa cacciarli proprio quando si dovrebbero aiutare. Le fiere non scacciano le fiere e l’uomo scaccerà l’uomo? Non sopportiamo che i cani stiano digiuni quando mangiamo, e scacciamo gli uomini?”
Non c’è bisogno di aggiungere altro.