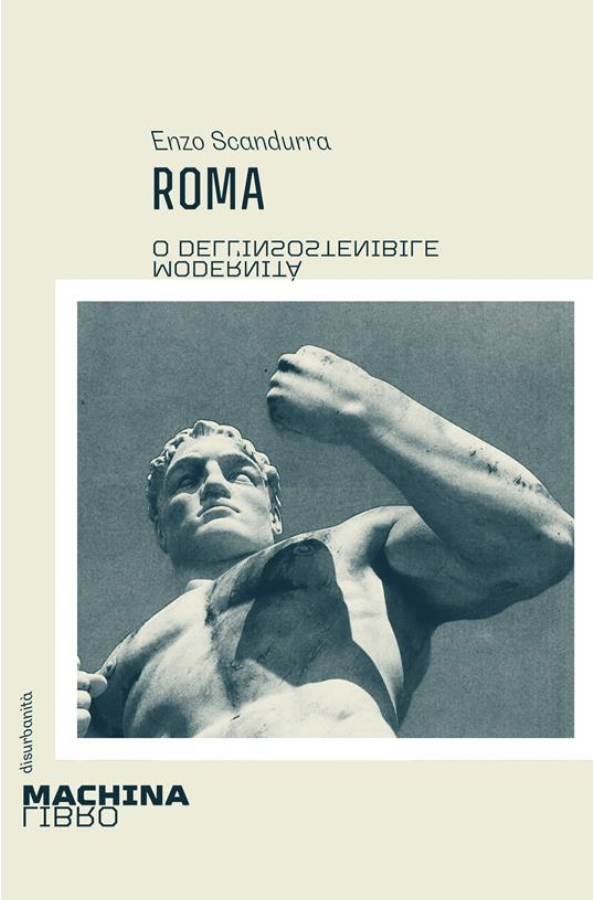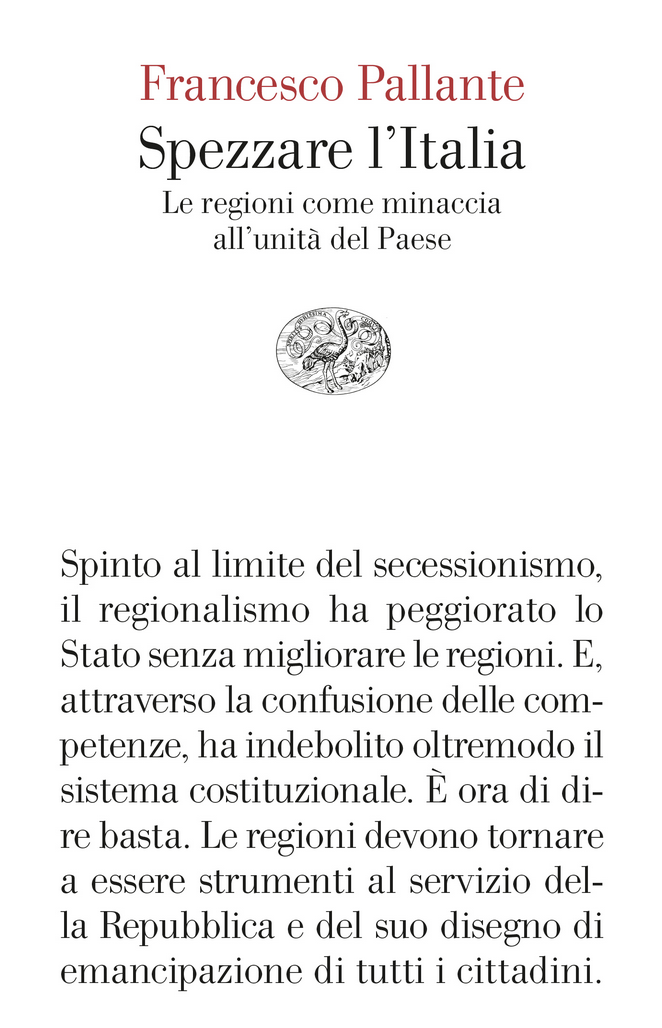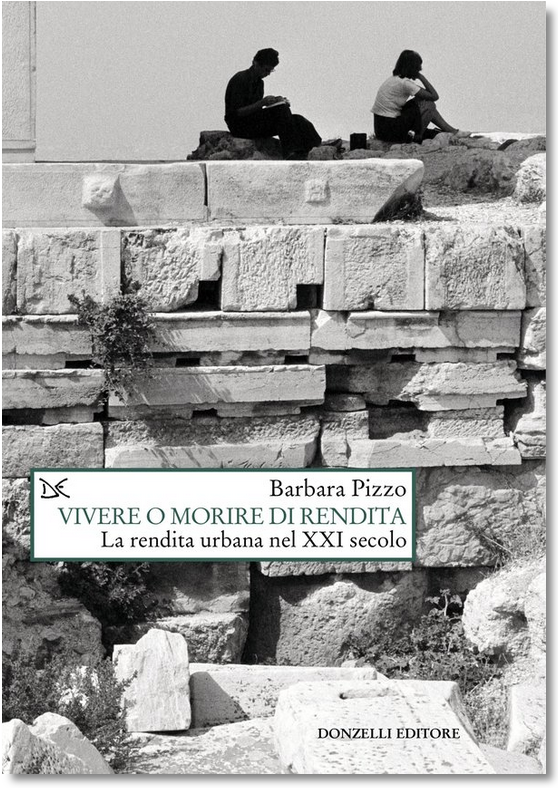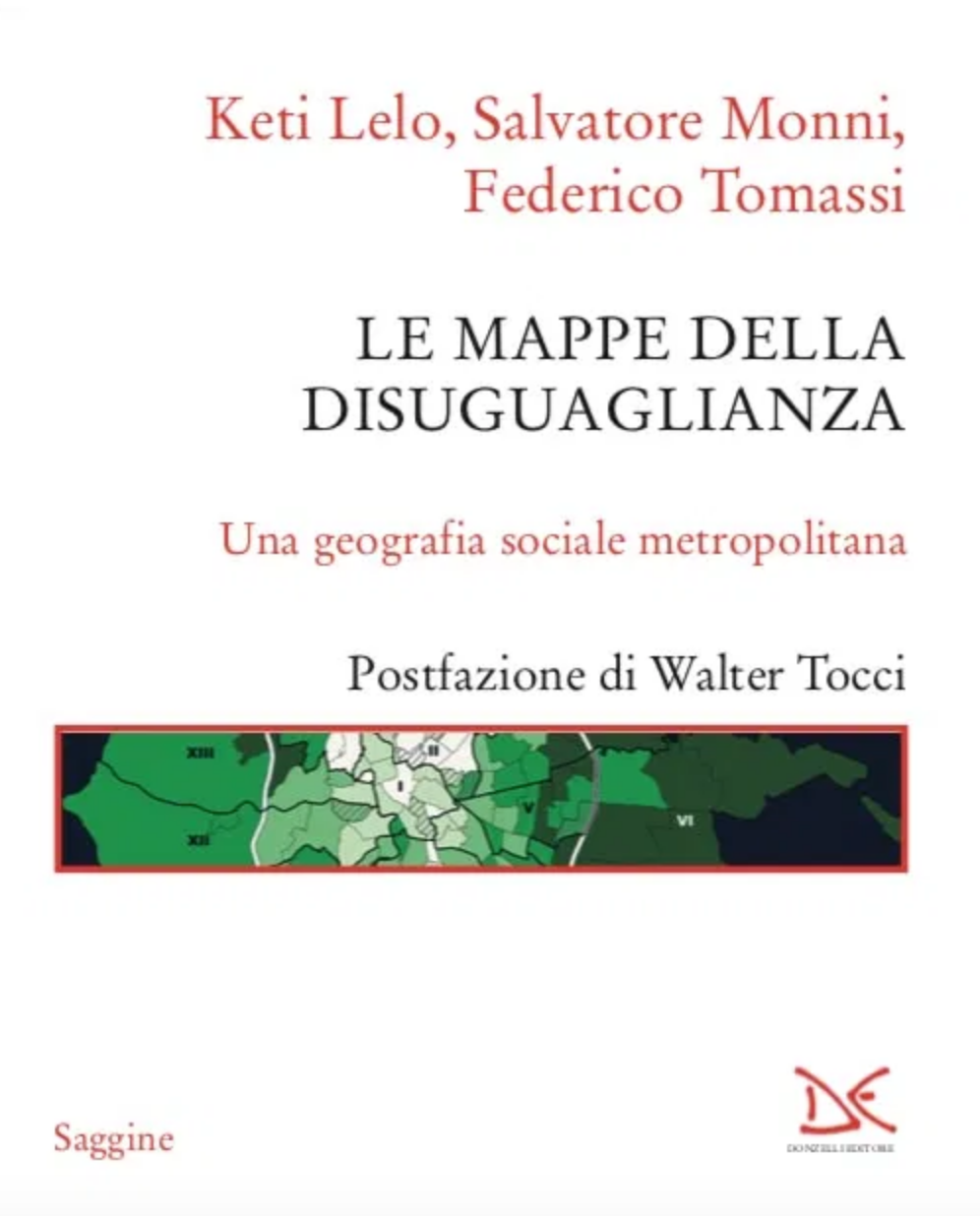- Home
- Chi siamo
- Chi siamo – il laboratorio
- Iscriviti alla newsletter
- Il Manifesto di Carteinregola
- Le nostre regole
- Rete di Carteinregola
- Le iniziative di Carteinregola dal dicembre 2020
- Tutte le nostre iniziative
- Fatti sentire! Impariamo a usare gli strumenti di comunicazione
- Censimento
- Piediperterra
- Piediperterra a Dragona e Dragoncello
- 1. Parco del Drago: appunti per una introduzione storica
- 2. Dragoncello: storia del Parco del Drago, Convenzione urbanistica PRU e progetti
- 3. Storia di Dragona
- 4. Dragona: il Museo D. Agostinelli
- 5. Dragona: il Punto Verde Qualità
- 6. Dragona: La stazione Acilia sud Dragona
- 7. Dragona – Dragoncello: Dorsale mare Tevere
- 8. Progetto Casale Dragoncello
- Piediperterra a San Lorenzo – Municipio II Roma
- Piediperterra a Testaccio
- Piediperterra a Casal Bertone – 5 luglio 2018
- Piediperterra 1
- Piediperterra 2 a Morena
- Spiazmoli! Piediperterra all’EUR 3- Spiazziamoli! IL PERCORSO
- Piedi per terra al Torrino sud il 20 gennaio 2017
- Piediperterra a Primavalle -28 aprile 2018
- Piediperterra a Dragona e Dragoncello
- Diario Presidio Campidoglio 2012-2013
- Dieci parole dell’ urbanistica
- Rassegna stampa
- Laboratorio
- La Mappa
- Calendario
- Istituzioni
- ISTITUZIONI
- Governo Italiano
- ROMA CAPITALE
- La consiliatura Gualtieri dal 2021
- Deliberazioni dell’Assemblea Capitolina dal 2021
- Deliberazioni della Giunta Gualtieri dal 2021
- Roberto Gualtieri Sindaco
- La Giunta Capitolina Gualtieri 2021
- Silvia Scozzese Vicesindaco e Assessore al Bilancio
- Sabrina Alfonsi, Assessore ai Rifiuti, Ambiente e Agricoltura
- Andrea Catarci Assessore al decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti
- Barbara Funari, Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute.
- Miguel Gotor, Assessore alla cultura
- Monica Lucarelli Assessore alle Attività produttive e Pari opportunità
- Alessandro Onorato Assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport
- Eugenio Patanè Assessore ai Trasporti
- Claudia Pratelli Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro
- Ornella Segnalini Assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture
- Tobia Zevi Assessore al Patrimonio e Politiche abitative
- Maurizio Veloccia – Assessore all’Urbanistica
- Assemblea Capitolina 2021
- Presidenti, Giunte, Consiglieri Municipi dal 2021
- Roma Capitale e CittàMetropolitana
- Le aziende partecipate del Comune di Roma
- Comune di Roma leggi norme e regolamenti
- La consiliatura Gualtieri dal 2021
- Elezioni a Roma
- Regione Lazio
- ISTITUZIONI
- PoliticaLab
- iDOSSIER
- Autonomia Regionale Differenziata, cronologia e materiali
- Modifiche al PRG di Roma
- PianoCasa/Legge rigenerazione urbana Lazio
- Progetto Porto turistico – crocieristico di Fiumicino – cronologia e materiali
- Affittacamere, case per vacanze, B&B a Roma e nel Lazio – cronologia e materiali
- Lago ex SNIA Viscosa – V Municipio
- Ex clinica Villa Bianca Cronologia
- Stadio Flaminio – II Municipio cronologia
- Circolo Poste e sotto ponte della Musica – cronologia e materiali
- Lago e area ex SNIA Viscosa – V municipio
- Regolamento del Verde di Roma
- PTPR – Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (del Lazio)
- PatrimonioComune cronologia materiali
- PUP Piano Urbano Parcheggi cronologia materiali
- ProgettoFlaminio
- DecretoTrasparenza
- V.I.A. Valutazione Impatto Ambientale
- Stadio Tor di valle cronologia
- Pineta di Villa Massimo (Punto Verde Infanzia) II Municipio
- Il Parco di Centocelle – V Municipio – cronologia e materiali
- Pianidizona
- PVQ
- MetroC
- Torri dell’EUR
- ForteTrionfale
- Autorecupero a scopo abitativo del patrimonio pubblico esistente – cronologia e materiali
- ATAC – cronologia e materiali
- BastaCartelloni
- iQuaderni
- Stadio Pietralata
- Modifiche al PRG
- Regolamento del Verde
- L’Italia non si taglia
- Giubileo 2025
- Urbanistica del Lazio 2023-24
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 1 (governo del territorio- interventi in zona agricola)
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 2 (rigenerazione urbana)
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 6 (valorizzazione degli immobili di proprietà pubblica)
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 7 (procedure di Valutazione Ambientale)
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 10 (strumenti attuativi)
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 13
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 15 (attività estrattive)
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 16 (aree sviluppo industriale)
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 17 (edilizia agevolata)
canlı casino siteleri online casino rottbet giriş rott bet güncel giriş
Widgetized Section
Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone
Enzo Scandurra – Gli Angeli non abitano più qui
 Periferie, relazione introduttiva
Periferie, relazione introduttiva
di Enzo Scandurra
leggi anche: Periferie, se la politica delega le archistar di Enzo Scandurra, 5.1.2015 (in calce)
Il senso del convegno
Il senso di questo convegno è quello di tentare di ridefinire, alla luce dei grandi cambiamenti che investono gli anni che vanno dal Cinquanta ad oggi, il concetto stesso di periferia e, dunque, di conseguenza quello di città. Per dirla in sintesi, tutti avvertiamo che tra quei paesaggi desolati (ma carichi di attese e speranza) degli anni appena successivi al dopoguerra che circondavano le grandi città, e le sterminate “periferie” di oggi, c’è solo qualche pallida analogia essendo mutate le composizioni sociali dei loro abitanti e perfino i caratteri antropologici, oltreché le condizioni politiche, urbanistiche, e le caratteristiche del modello economico. Per questo abbiamo scelto come titolo del convegno, un verso di Pasolini ribaltato di senso.
Ma per capire quali siano questi cambiamenti che rendono perfino astratto o privo di senso l’accostamento delle vecchie periferie a quelle odierne, occorre fissare una data dopo la quale prende avvio questo cambiamento.
Le periferie storiche
Sulle periferie degli anni Cinquanta e Sessanta c’è una vasta letteratura che va dai romanzi alle opere cinematografiche. La prima fase, tra il 1943 e il 1955, è quella dei film neorealisti di Visconti, Germi, De Sica, De Santis. Ci descrivono una Roma post-bellica, una città provinciale che coincideva con la sua parte storica ancora non colonizzata dai turisti. Qualche anno dopo, tra il 1950 e il 1960, il genio profetico di Pasolini è riuscito a rappresentare la grande trasformazione di quegli anni: la fine di un mondo contadino e il dramma del sottoproletariato urbano, entrambi in via di cancellazione dalla storia con l’avvento delle prime manifestazioni di modernità (che per Pasolini, significava soprattutto consumismo). La letteratura sociologica e antropologica poneva intanto la sua attenzione su quello straordinario mondo di immigrati dal sud e contadini inurbati che si accampava a ridosso delle mura e che dava vita a inedite tipologie urbanistiche: borgate, borghetti, baraccamenti. Sono da ricordare le analisi di Ferrarotti e Macioti[1], le foto di Pinna[2], le testimonianze di vita come quella di don Sardelli all’Acquedotto Felice[3], le descrizioni dei grandi scrittori romani “d’origine” come Moravia o Elsa Morante, quella degli scrittori d’adozione come Caproni, Gadda, Gatto, Penna, Bertolucci. La città, per la prima volta, si estendeva oltre le sue storiche mura, invadeva l’agro, la campagna romana; nascevano le (nuove) periferie che accoglievano il nuovo ceto impiegatizio, soprattutto coloro che, in città, riuscivano a trovare lavoro nelle aziende municipalizzate o nelle ferrovie. Da allora narrazioni importanti come quelle sopra citate non ce ne sono più state.
Quelle periferie, allora lontane, quasi sconosciute, una volta evocate sono entrate a far parte della storia moderna di Roma, le si sono – potremmo dire – “appiccicate addosso” come una pelle: non c’è una Roma antica e una Roma moderna – diceva Pasolini – ma solo una, antica e moderna contemporaneamente. Nelle periferie storiche l’emarginazione, le disuguaglianze venivano elaborate – ricorda Walter Tocci – tramite un altrove temporale, un’utopia di buona società, da raggiungere attraverso l’emancipazione. In sostanza, le periferie storiche non erano soltanto luoghi di disperazione, di solitudine, di disincanto; piuttosto luoghi carichi di speranza, dell’attesa di un riscatto. In esse trovava consenso e faceva proseliti il “vecchio” Partito Comunista che tra i suoi obiettivi politici comprendeva il progetto del riscatto di questo popolo contro il potere e il dominio delle grandi famiglie di proprietari di terreni e immobiliari poi[4]. Questo atteggiamento di solidarietà si traduceva nel sostegno del PCI alla realizzazione di servizi, fogne, scuole. Ma ben presto le pessimistiche profezie di Pasolini trovarono conferma: negli anni Ottanta, avendo ormai ottenuto la sanatoria, i “borgatari” cominciarono a ragionare come proprietari immobiliari, trovando nella destra risposte più adeguate, fino allo smantellamento, verso la fine di quegli anni, delle tradizionali “roccaforti rosse” delle borgate abusive, diventate rapidamente egemonia della destra[5]
Da quegli anni in poi, con l’avvento del “mondo moderno”, studi e ricerche sulle periferie romane hanno subito un arresto o, nel migliore dei casi, hanno descritto frammentariamente episodi, spezzoni di realtà, via via che le periferie si allontanavano da quelle immagini stereotipe trasformandosi in qualcosa di profondamente diverso e, come sostiene Ferrarotti: “accontentandosi di ricerche frammentarie, tanto tecnicamente raffinate quanto sostanzialmente prive di significato”[6]. Oggi sono oggetto di attenzione per gli episodi di cronaca nera e di esplosioni di rabbia sociale.
La grande mutazione delle periferie
L’episodio che ha fatto uscire dal torpore le amministrazioni di sinistra sulle trasformazioni avvenute in questi territori, è stato, a Roma, l’esito straordinario delle votazioni cittadine sullo scontro elettorale tra l’ex Sindaco Rutelli e il suo rivale Alemanno, nel 2008, al termine di un quindicennio di ininterrotto governo del centro sinistra e appena due anni dopo che lo stesso Veltroni alle comunali del 2006 aveva raccolto il 62% dei voti. Le analisi dei risultati del voto dimostrarono come a sconfiggere la sinistra erano stati proprio i voti delle periferie romane un tempo serbatoi privilegiati, “cinture rosse” contro il voto delle aree centrali della città tradizionalmente di destra e ora “inspiegabilmente” diventate sostenitrici dell’esperimento riformista delle amministrazioni di sinistra. Si parlò, a quel tempo, di risentimento e di rancore nei riguardi di una sinistra che aveva abbandonato alla destra il presidio di quei territori, volgendo le spalle agli abitanti delle periferie[7]. Il libro di Siti, Il contagio, seppure in forma di romanzo, costituisce una svolta dell’immagine tradizionale e stereotipata delle vecchie periferie. Le borgate romane descritte da Siti vanno trasformandosi in una poltiglia indistinta ammaliata dai nuovi valori borghesi del consumismo abbandonando ogni speranza di rigenerarsi, ogni illusoria attesa di un mitico riscatto sociale, rompendo i vecchi legami solidali e arcaici che tanto avevano affascinato Pasolini, innescando una diffidenza di ciascuno contro ogni altro, abbandonandosi nella disperazione degli “ultimi” condannati a rimanere tali per sempre[8].
Un sintomo oggettivo di questa trasformazione delle periferie è costituito dal fatto che a fronte di un allargamento del benessere dagli anni Cinquanta- Sessanta ad oggi, “il mondo periferico non si restringe, non indietreggia. Anzi il mondo periferico avanza”[9]. Oggi possiamo ben dire, fuori da metafora, che la città, Roma in particolare, è una gigantesca periferia, essendo il suo centro un luogo residuale di vita, spesso un vero e proprio museo ad uso e consumo del turismo predatorio. Quello di periferia è diventato pertanto un concetto estendibile a gran parte del mondo moderno fuori dall’Occidente così come interno ad esso, spesso presente e osservabile nel cuore stesso della città.
Il mondo si periferizza
Questo perché quello che chiamiamo benessere è una assolutamente squilibrata distribuzione delle ricchezze, portatrice di più accentuate disuguaglianze che non eliminano le periferie ma ne estendono l’area d’influenza sulle città secondo lo slogan “siamo il 99%”: “Chi appartiene all’1% se ne sta andando con i soldi, ma nel frattempo non ha procurato se non angoscia e insicurezza al restante 99%. La maggioranza degli americani semplicemente non ha tratto alcun vantaggio dalla crescita del paese”[10]. E quello che Stiglitz afferma per il popolo americano ha indubbio valore per ogni altro popolo occidentale. “Per anni” sostiene Stiglitz “è esistito un patto tra chi stava in alto e il resto della società e il patto era più o meno questo: noi vi daremo lavoro e prosperità mentre voi ci lascerete liberi di portarci a casa i nostri bonus. In altre parole: voi avrete la vostra parte, anche se noi ne avremo una più grande”. Oggi quel tacito accordo (welfare, dico io) tra i ricchi e il resto degli americani, che era comunque fragile, è andato in pezzi”[11]. Se il welfare, conquista di classi lavoratrici in lotta con il capitale per conquistare il diritto alla città, è diventato un “lusso” ormai insostenibile producendo un progressivo del 99% della popolazione, si è venuta al tempo stesso “a creare una nuovo e crescente disuguaglianza tra le generazioni e le categorie sociali che hanno potuto ammortizzare almeno in parte gli effetti della crisi e tutte quelle che non sono state in condizioni di farlo”[12]. Così che, aggiunge Cassano, “Questa circostanza ha dislocato il rapporto tra la sinistra e la società, logorando sempre più la sua capacità di rappresentare gli ultimi e consumando la coesione del suo popolo”.
Queste poche righe sembrano già sufficienti a spiegare la condizione di miseria e di disperazione che affligge le nostre periferie sempre più estese. Al tempo stesso tale condizione si trasforma da “temporanea” a “permanente”, cronica perché la disuguaglianza iniziale tende a moltiplicarsi ad ogni giro moltiplicandosi esponenzialmente. Questo processo può giustificare lo scetticismo di quanti sostengono che ogni tentativo di rigenerazione delle periferie, ogni tentativo di “rammendo”[13] è, in questa condizione generale, destinato all’insuccesso, ancorché lodevole nelle sue intenzioni di ridistribuire il benessere prodotto.
La lotta di tutti contro tutti
Accanto ai conflitti derivanti da queste condizioni, ci sono, secondo Franco Cassano, altri conflitti che nascono proprio dall’espansione generale dei diritti. Per esempio, egli sostiene che: “il sacrosanto diritto all’accoglienza degli immigrati può entrare in conflitto con la percezione della sicurezza in quegli strati popolari che avvertono i nuovi arrivati come un pericolo per i propri diritti acquisiti, da quello del lavoro a quello della sicurezza”[14]. Il tema della convivenza rischia dunque di ridursi a un generico appello di stampo moralista se non si rimuovono le cause che producono le insicurezze.
Così come la caduta del mito della soluzione individualistica con la sua prospettiva di ascesa sociale (La società non esiste, esistono solo gli individui, affermava la Thatcher), che è stato un formidabile complice dell’egemonia esercitata dal neoliberalismo, tende ora, nelle nostre periferie, a trasformarsi in un sentimento di rivolta contro tutti. Tra queste promesse tradite, Cassano annovera anche il mito del merito che, in queste condizioni, rappresenta “quella dinamica che risucchia nelle aree più forti i più coraggiosi e capaci aumentando in modo esponenziale il divario preesistente e rendendo sempre più ineguali i punti di partenza”.
Da quanto sia pur approssimativamente descritto, appare già facilmente osservabile come le “vecchie” periferie siano sideralmente distanti da quelle che continuiamo a chiamare “nuove” periferie che costituiscono le condizioni generali di vita del 99% delle persone che rappresentano la città contemporanea nella quale “c’è chi naviga ad alta velocità, chi nuota e chi affoga senza pietà[15]”.
Il “che fare?”
La sfida, o la scelta, che ci si pone di fronte è tra la disperazione (there is not alternative, o come dice Siti: resistere non serve a niente) e la speranza, dove questa non deve trarre la sua forza da una prospettiva di un mitico e futuro altrove, ma dai tentativi di dare ora risposte nuove che non siano più quelle delle vecchie nomenclature politiche.
Non ci si deve meravigliare che nelle ormai sconfinate ed estreme periferie romane, là dove il legame sociale si è indebolito, dove non trova più spazio alcuna rappresentanza, dove ogni istituzione intermedia tra amministrazione e cittadini è saltata, ebbene in questi luoghi cresce la sfiducia nei confronti della politica. In tal senso le periferie perdono potere e ritornano brevemente alla ribalta solo in occasioni di esplosioni di rabbia popolare o episodi di cronaca nera. Secondo Tocci: “Per restituire potere alla periferia occorre, invece, aiutare la dimensione orizzontale della partecipazione, sia rilanciando l’attività dei circoli – secondo nuove modalità tutte da inventare – sia ripensando i municipi come istituzioni non burocratiche che danno voce ai territori”. Ma ormai neppure questo può bastare a restituire dignità, identità e fiducia al popolo delle periferie. Occorre reinventare una pratica progettuale, aprire le finestre di un futuro diverso, rimettere in moto la discussione politica.
I tentativi del quindicennio rosso di Rutelli e Veltroni sul versante urbanistico hanno prodotto un PRG che già in fase di approvazione risultava invecchiato, perché ha tentato di creare delle “nuove centralità” nelle periferie che altro non sono che “grumi di palazzine addossate ai grandi centri commerciali, sconnesse dalla città e accessibili solo con l’automobile”[16]. In questo periodo “quasi tutte le nuove edificazioni sono state collocate a ridosso del Gra, realizzando tanti quartieri isolati tra loro e sempre più lontani dal centro, in un territorio già devastato dall’abusivismo e privo di robuste strutture urbane. Ciò ha appesantito la vita quotidiana dei cittadini, sia di quelli che già vi abitavano sia dei nuovi venuti, e ha aumentato il pendolarismo tra una periferia sempre più lontana e i luoghi centrali di lavoro, fino a produrre l’ingorgo permanente sulle consolari. Di tutto ciò, come si è detto, si è pagato anche un prezzo politico con lo spostamento a destra dell’elettorato della periferia anulare”[17].
Potremmo dire che il centro della città si sposta progressivamente verso le periferie, si va anch’esso periferizzandosi. Eppure è nelle pieghe di questa contraddizione, tra marginalità e abbandono, da una parte, e riconquista e trasformazione dei luoghi dove si svolge la vita quotidiana che possono svilupparsi pratiche sociali e di vita comunitaria antagoniste alla vecchia centralizzazione verticistica. “Sono solo esempi di processi latenti dotati di una chimica endogena che può portare ad esiti diversi, sia di inevitabile degrado sia di possibile riforma. Sfuggono alle semplificazioni della politica mediatizzata, che infatti non li vede oppure li spiana con strumenti normativi ed emergenziali. Per trarne gli aspetti positivi ci vuole un governo di prossimità che faccia da catalizzatore delle energie più innovative”[18].
[1] Cfr. di Franco Ferrarotti (1970), Roma da capitale a periferia, Laterza, Bari, e il successivo Vite di baraccati (1973), ricco di una cinquantina di fotografie di vie, baracche e borgatari; seguirà, di F. Ferrarotti e altri (1980) , Vite di periferia, Mondadori, Milano; e più recentemente, di F. Ferrarotti e Maria I. Macioti (2009), Periferie da problema a risorsa, Sandro Teti Editore, Roma.
[2] Franco Pinna, che ha lavorato con i più noti antropologi del suo tempo, ha lasciato un importante archivio; da ricordare le pubblicazioni di sue importanti foto ne L’isola del rimorso. Fotografie in Sardegna, 1953-1967, di Giuseppe Pinna; Con gli occhi della memoria. La Lucania nelle fotografie di Franco Pinna, 1952-’59, di Giuseppe Pinna ( Ed. Il ramo d’oro, Trieste 2002); Fotografie 1944-1977 (Milano 1996). Pinna è stato un giovane militante del PCI, partito in cui è rimasto fino ai fatti dell’Ungheria. Ha lavorato con Giovanni Berlinguer nelle sue ricerche sulle borgate romane. Importante la sua collaborazione con Ernesto De Martino, con Franco Cagnetta, il noto autore di Banditi a Orgosolo. Le sue foto sono una importante testimonianza visiva della storia italiana.
[3] Don Roberto Sardelli negli anni ’60 a Roma ha aperto all’Acquedotto Felice una scuola, detta scuola 725, per i bambini e i ragazzi che vivevano in borgata, seguendo un po’ le orme di don Lorenzo Milani . Tra i suoi scritti più conosciuti, v. Non tacere, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1970; In borgata, ed. Nuova Guaraldi, Firenze 1980; su don Sardelli v. altresì la tesi di laurea di Antonella Macellaro, Don Roberto Sardelli e la scuola 725. Un’esperienza di riscatto sociale e di lotta alla dispersione scolastica, Sapienza Università di Roma, Facoltà di filosofia, a.a. 2009/2010, relatore il prof. Guido Benvenutoe il successivo testo di Katia Scannavini e Maria Immacolata Macioti, Il valore del sapere. L’esperienza della Scuola 725, studio voluto dalla Provincia di Roma, Assessorato alle Politiche Culturali, contenente un dvd La scuola 725, con interviste ai protagonisti di allora, a cura di Enzo Pompeo e Luca Ricciardi.
[4] Cfr. Enzo Scandurra (2014), Quo Vadis Roma?, articolo su «Il Manifesto» 27 marzo 2015
[5] In proposito si legga l’ampio saggio di W. Tocci: Non si piange su una città coloniale. Note sulla politica romana, dattiloscritto non pubblicato
[6] F:Ferrarotti (2008), Considerazioni intorno alla periferia romana, in AA.VV., Capitale di cultura. Quindici anni di cultura a Roma, Donzelli, Roma.
[7] Il libro di W. Siti, Il contagio, (Mondadori) uscito nel 2008, rappresenta, più di tante analisi, la testimonianza diretta delle trasformazioni in atto nelle borgate romane. Spesso viene citata, a proposito, l’espressione che Siti pronuncia in merito all’atteggiamento del popolo delle periferie nei confronti dell’esperimento riformista di Rutelli-Veltroni: “mai visto un borgataro riformista”.
[8] Nel saggio di W. Tocci, citato precedentemente si fa un’interessante distinzione tra periferia storica e periferia anulare: “Molto diverso, quindi, fu il contributo del Pci nella periferia anulare e in quella storica. Negli insediamenti abusivi portò a compimento una rivendicazione di infrastrutture primarie senza influenzare il senso comune della gente che infatti passò a destra dopo la sanatoria. Nella seconda, invece, svolse una funzione di educazione alla politica che influì sulle corde profonde del sentimento popolare, tanto da mantenere un orientamento a sinistra ancora ai giorni nostri, pur in condizioni sociali e culturali radicalmente diverse. La politica di oggi, così abituata alla battuta di giornata, fatica a capire quanto il consenso sia condizionato da processi di lunga durata”.
[9] F. Ferrarotti, op. cit., p.230
[10] Joseph E. Stiglitz (2013), Il prezzo della disuguaglianza. Come la società divisa di oggi minaccia il nostro futuro, Torino, Einaudi, p. XVIII
[11] Op.cit., p. XVIII
[12] F. Cassano (2014), Senza il vento della storia. La sinistra all’epoca del cambiamento, Roma-Bari, Laterza, p.62.
[13] Con esplicito riferimento a quella operazione organizzata da Renzo Piano che va sotto il nome di “Rammendo delle periferie”.
[14] F. Cassano, op. cit., p.65
[15] F. Cassano, op. cit., p. 77
[16] W. Tocci, dattiloscritto, op. cit.
[17] W. Tocci, op. cit.
[18] W. Tocci, op. cit.
Periferie, se la politica delega le archistar
— Enzo Scandurra, 5.1.2015
Urbanistica . Il “progetto di rammendo” di Renzo Piano, pur originale e privo di sensazionalismi, non basta a risolvere la questione sociale. Dimenticate da tutti, perfino da urbanisti e sociologi, le diseguaglianze sono il vero motore delle rivolte
Cessato l’allarme, la “questione periferie” torna nel cono d’ombra dei media come fosse stata un fenomeno isolato e passeggero, un capriccio di una parte della città delusa e abbandonata. Ora c’è il “progetto di rammendo” affidato a Renzo Piano e al suo gruppo di lavoro G124, e così la politica passa volentieri la mano (meglio sarebbe dire la palla) all’architettura e all’urbanistica, rinunciando al suo ruolo guida.
È invece utile non sottovalutare quanto è successo nelle nostre periferie (e quello che potrebbe ancora accadere) ricordando le parole di una lunga intervista a Foucault («spazio, sapere e potere») a chi gli chiedeva quale fosse il ruolo dell’urbanistica e dell’architettura nella società moderna: «All’inizio del XVII secolo si smette di concepire la città come un luogo privilegiato, come un’eccezione all’interno di un territorio costituito da campi, foreste e strade. D’ora in poi le città, con i problemi che sollevano e le configurazioni particolari che assumono, servono da modelli per una razionalità di governo che verrà applicata all’insieme del territorio».
E del resto lo stesso Renzo Piano conferma come «il grande progetto del nostro Paese sia quello delle periferie: la città del futuro, la città che sarà, quella che lasceremo in eredità ai nostri figli. Sono ricche di umanità, qui si trova l’energia e qui abitano i giovani carichi di speranze e voglia di cambiare». Tuttavia incalzato dai suoi allievi che gli chiedono se certi progetti architettonici possono rappresentare delle forze di liberazione o, al contrario, delle forze di resistenza, Foucault risponde: «La libertà è una pratica. Dunque può sempre esistere in effetti un certo numero di progetti che tendono a modificare determinate costrizioni, ad ammorbidirle, o anche ad infrangerle, ma nessuno di tali progetti, semplicemente per propria natura, può garantire che la gente sarà automaticamente più libera». Il contributo di Renzo Piano al problema delle periferie, sia pure mosso da buoni propositi, ha il punto debole (non imputabile a lui) nell’affrontare la questione solo nella direzione dell’architettura e dell’urbanistica: «Si deve intensificare la città, costruire sul costruito, sanare le ferite aperte. Di certo non bisogna costruire nuove periferie oltre a quelle esistenti: devono diventare città ma senza espandersi a macchia d’olio, vanno ricucite e fertilizzate con strutture pubbliche.È necessario mettere un limite a questo tipo di crescita, non possiamo più permetterci altre periferie remote, anche per ragioni economiche». Su questa questione, nel procedere dell’intervista, Foucault si esprime con molta determinazione: «Penso che l’architettura (e l’urbanistica, ndr) possa produrre, e produca, degli effetti positivi quando le intenzioni liberatorie dell’architetto coincidono con la pratica reale delle persone nell’esercizio delle loro libertà».
Ora bisogna riconoscere che Renzo Piano è uno dei più bravi architetti italiani per cultura, serietà e professionalità, ma ha ragione Emanuele Picardo ad affermare su questo stesso giornale (il manifesto del 30/12/2014) che: «Affrontare la periferia solo con lo sguardo dell’architetto è un peccato originale che ne impedisce una lettura complessa e articolata». E qui è necessario restituire di nuovo la parola a Foucault: «L’esercizio della libertà non è del tutto insensibile alla distribuzione degli spazi, ma esso può funzionare soltanto dove si dà una certa convergenza; se vi è divergenza o distorsione l’effetto prodotto è immediatamente contrario a quello ricercato». Questo è quello che è accaduto al progetto rutelliano delle «cento piazze». Alcune di esse, come a San Basilio hanno avuto un certo successo; altre, come al Quarticciolo, stanno per essere smantellate perché gli abitanti le sentono estranee e vogliono ritornare alla piazza che c’era negli anni ’50.
Dunque un progetto architettonico-urbanistico o viene concepito e realizzato direttamente (e autoritariamente) dal Principe, oppure, in epoca moderna, non può che scaturire (sia pure con l’autonomia necessaria) all’interno di una cornice politica che detta una propria visione della società, una politica intesa come mediazione di interessi in gioco, interpretazione dei bisogni, espliciti o meno, degli abitanti che quei luoghi li abitano e li attraversano quotidianamente. Se la politica delega in toto la soluzione dei problemi sociali all’architettura e all’urbanistica, il progetto che ne consegue risulta monco, affidato al libero arbitrio (ed estro) del suo Progettista che viene gravato di un compito improprio e improbo, ovvero quello di risolvere questioni sociali che non gli competono direttamente, il che facilmente degenera in opere autocelebrative che a Roma, per fare un esempio, si chiamano la “Nuvola” o lo “Stadio del nuoto” (e rimane solo da sperare che tra di esse non compaia infine anche il nuovo stadio della Roma a Tor di Valle).
È vero che il “progetto di rammendo” di Piano ha una sensibilità diversa e si rivolge ai quartieri periferici senza cercare effetti sorprendenti né sensazionalismi e utilizzando poche risorse (poco più dello stipendio di senatore a vita messo a disposizione da Piano), ma è la cornice politica che manca, ciò che a suo tempo dava senso alle geniali iniziative di Nicolini nello scenario politico impostato da Petroselli. Perché a fronte di tante demagogie populiste bisogna pur affermare e difendere l’autonomia delle scelte progettuali — architettoniche o urbanistiche — che mai debbono essere piegate al volere dei poteri dominanti quale che siano, come avveniva già nel Rinascimento.
Una delle principali condizioni che distingue le attuali periferie da quelle degli anni ’50 e ’60 è la crescita progressiva delle disuguaglianze sociali. Anche nelle prime periferie urbane, la causa del degrado nasceva dalle condizioni di povertà ma, all’epoca, c’era l’attesa e la quasi certezza che lo sviluppo e il benessere prima o poi, avrebbe raggiunto tutti gli strati sociali. Queste condizioni di povertà sono diventate ora strutturali, croniche, fisiche, esistenziali, trasformate in condizioni di miseria, senza che si abbia più la percezione che esse possano migliorare, in un quadro sociale imbarbarito dove prevale il morbo individualista del «speriamo che io me la cavo».
E al tempo stesso la questione sociale al centro di tante e famose opere letterarie dell’800 e della prima metà del ’900, da Zola a Steinbeck, da Balzac ad Hugo, come affermava qualche giorno fa Alberto Asor Rosa su La Repubblica, «non vive più nelle coscienze delle persone. La percezione e la condanna delle disuguaglianze sociali è stata respinta ai margini, non interessa». La stessa sorte capita agli urbanisti, ai sociologi, agli antropologi per i quali la questione delle disuguaglianze in quanto suddivisione della società tra chi possiede molto e chi non possiede niente, si consuma e si dissolve nella ricerca di improponibili soluzioni specialistiche.
Perfino i giovani ricercatori la aggirano: anche loro indagano casi particolari, segmentazioni sociali, quasi che questi fossero isolabili dal contesto sociale più generale. Ci si occupa di rifugiati, profughi, Rom, barboni, occupanti di case, storie isolate di vicende personali. È come se questa società si fosse fatta distratta, avesse rimosso il tema del conflitto sociale e non tenesse più in conto di quello che Stiglitz chiama il prezzo della disuguaglianza, il vero motore delle rivolte. Se il mondo diventa sempre più duale e la periferia rappresenta quel 99% di chi non possiede niente che assedia le comunità blindate di quel l’1% che possiede tutto, la soluzione può essere solo quella di cambiare direzione, e politica.