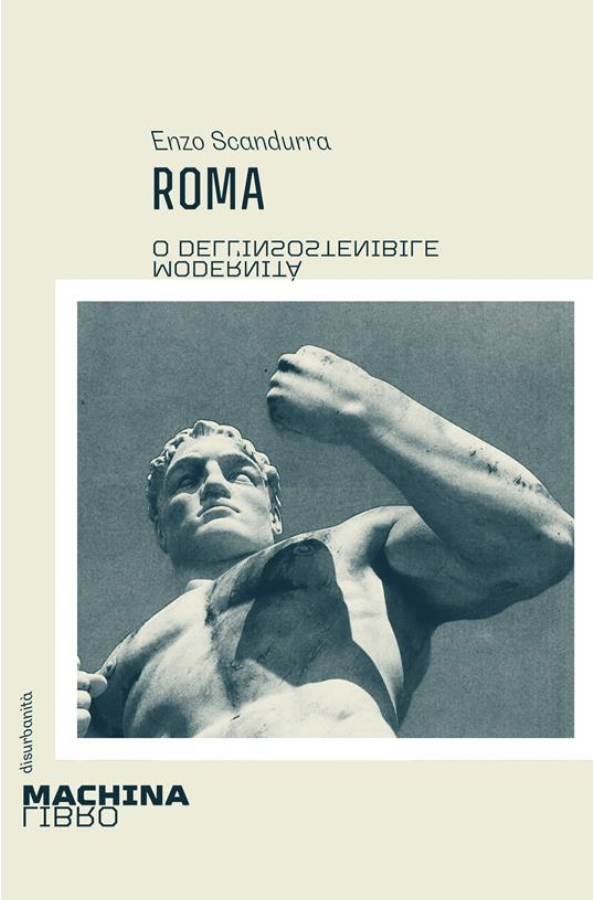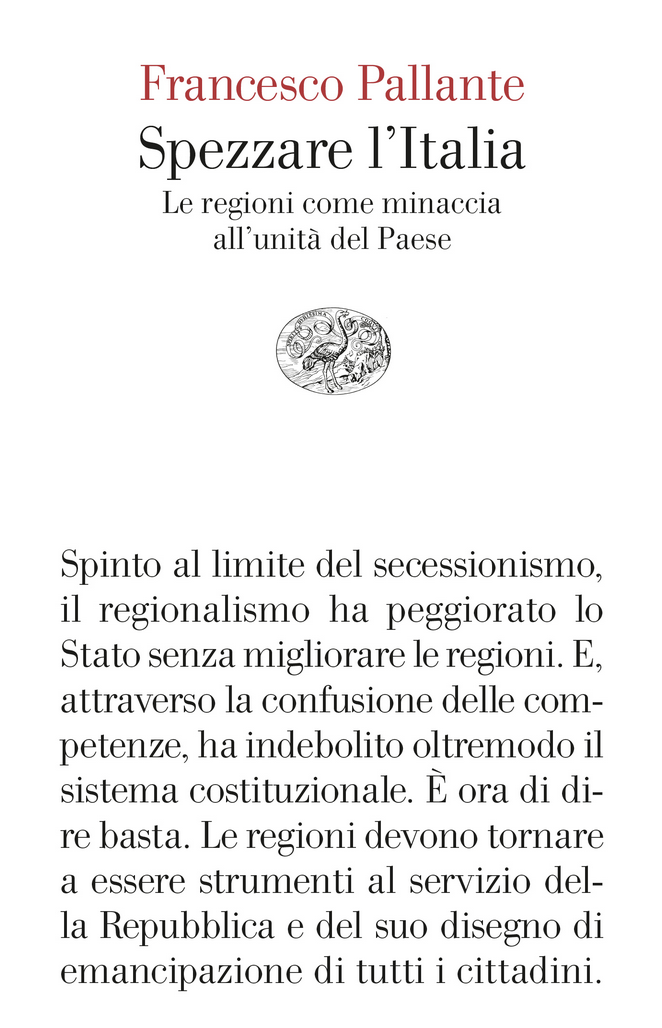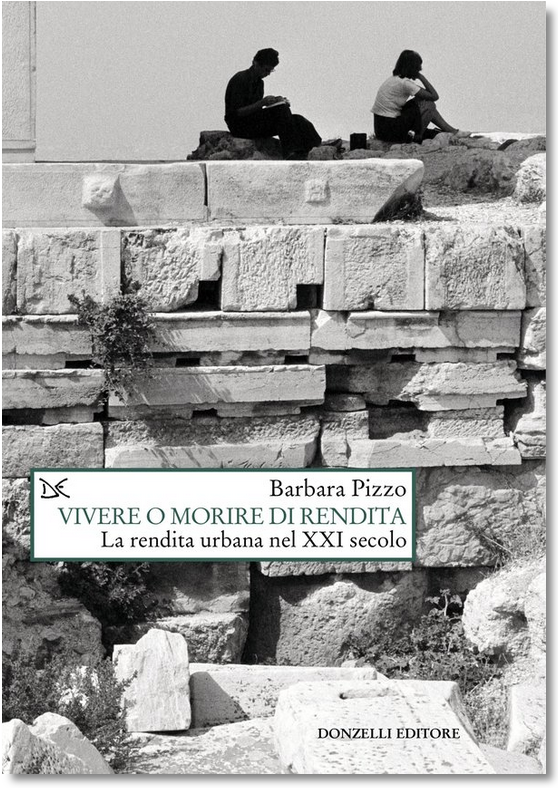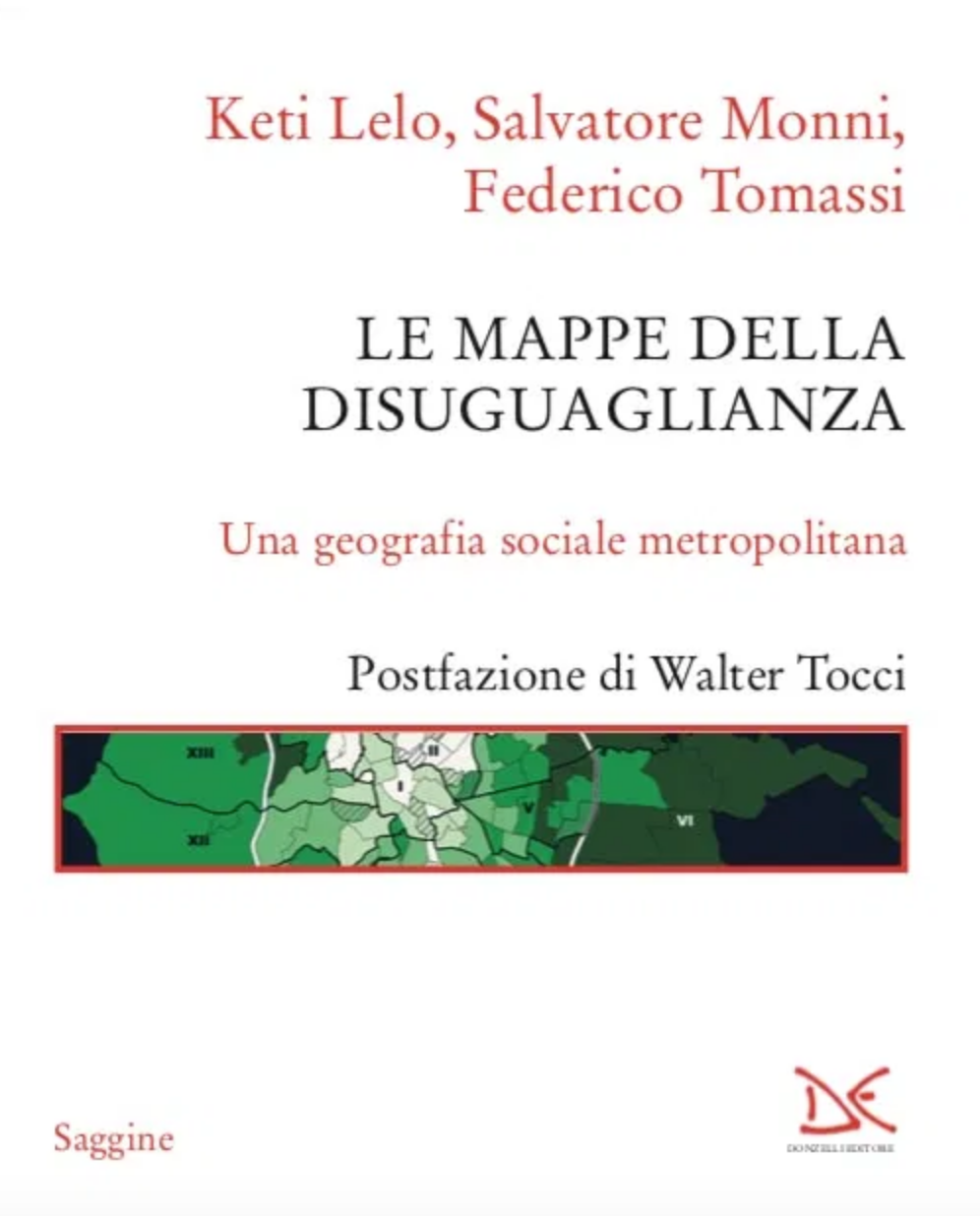- Home
- Chi siamo
- Chi siamo – il laboratorio
- Iscriviti alla newsletter
- Il Manifesto di Carteinregola
- Le nostre regole
- Rete di Carteinregola
- Le iniziative di Carteinregola dal dicembre 2020
- Tutte le nostre iniziative
- Fatti sentire! Impariamo a usare gli strumenti di comunicazione
- Censimento
- Piediperterra
- Piediperterra a Dragona e Dragoncello
- 1. Parco del Drago: appunti per una introduzione storica
- 2. Dragoncello: storia del Parco del Drago, Convenzione urbanistica PRU e progetti
- 3. Storia di Dragona
- 4. Dragona: il Museo D. Agostinelli
- 5. Dragona: il Punto Verde Qualità
- 6. Dragona: La stazione Acilia sud Dragona
- 7. Dragona – Dragoncello: Dorsale mare Tevere
- 8. Progetto Casale Dragoncello
- Piediperterra a San Lorenzo – Municipio II Roma
- Piediperterra a Testaccio
- Piediperterra a Casal Bertone – 5 luglio 2018
- Piediperterra 1
- Piediperterra 2 a Morena
- Spiazmoli! Piediperterra all’EUR 3- Spiazziamoli! IL PERCORSO
- Piedi per terra al Torrino sud il 20 gennaio 2017
- Piediperterra a Primavalle -28 aprile 2018
- Piediperterra a Dragona e Dragoncello
- Diario Presidio Campidoglio 2012-2013
- Dieci parole dell’ urbanistica
- Rassegna stampa
- Laboratorio
- La Mappa
- Calendario
- Istituzioni
- ISTITUZIONI
- Governo Italiano
- ROMA CAPITALE
- La consiliatura Gualtieri dal 2021
- Deliberazioni dell’Assemblea Capitolina dal 2021
- Deliberazioni della Giunta Gualtieri dal 2021
- Roberto Gualtieri Sindaco
- La Giunta Capitolina Gualtieri 2021
- Silvia Scozzese Vicesindaco e Assessore al Bilancio
- Sabrina Alfonsi, Assessore ai Rifiuti, Ambiente e Agricoltura
- Andrea Catarci Assessore al decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti
- Barbara Funari, Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute.
- Miguel Gotor, Assessore alla cultura
- Monica Lucarelli Assessore alle Attività produttive e Pari opportunità
- Alessandro Onorato Assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport
- Eugenio Patanè Assessore ai Trasporti
- Claudia Pratelli Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro
- Ornella Segnalini Assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture
- Tobia Zevi Assessore al Patrimonio e Politiche abitative
- Maurizio Veloccia – Assessore all’Urbanistica
- Assemblea Capitolina 2021
- Presidenti, Giunte, Consiglieri Municipi dal 2021
- Roma Capitale e CittàMetropolitana
- Le aziende partecipate del Comune di Roma
- Comune di Roma leggi norme e regolamenti
- La consiliatura Gualtieri dal 2021
- Elezioni a Roma
- Regione Lazio
- ISTITUZIONI
- PoliticaLab
- iDOSSIER
- Autonomia Regionale Differenziata, cronologia e materiali
- Modifiche al PRG di Roma
- PianoCasa/Legge rigenerazione urbana Lazio
- Progetto Porto turistico – crocieristico di Fiumicino – cronologia e materiali
- Affittacamere, case per vacanze, B&B a Roma e nel Lazio – cronologia e materiali
- Lago ex SNIA Viscosa – V Municipio
- Ex clinica Villa Bianca Cronologia
- Stadio Flaminio – II Municipio cronologia
- Circolo Poste e sotto ponte della Musica – cronologia e materiali
- Lago e area ex SNIA Viscosa – V municipio
- Regolamento del Verde di Roma
- PTPR – Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (del Lazio)
- PatrimonioComune cronologia materiali
- PUP Piano Urbano Parcheggi cronologia materiali
- ProgettoFlaminio
- DecretoTrasparenza
- V.I.A. Valutazione Impatto Ambientale
- Stadio Tor di valle cronologia
- Pineta di Villa Massimo (Punto Verde Infanzia) II Municipio
- Il Parco di Centocelle – V Municipio – cronologia e materiali
- Pianidizona
- PVQ
- MetroC
- Torri dell’EUR
- ForteTrionfale
- Autorecupero a scopo abitativo del patrimonio pubblico esistente – cronologia e materiali
- ATAC – cronologia e materiali
- BastaCartelloni
- iQuaderni
- Stadio Pietralata
- Modifiche al PRG
- Regolamento del Verde
- L’Italia non si taglia
- Giubileo 2025
- Urbanistica del Lazio 2023-24
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 1 (governo del territorio- interventi in zona agricola)
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 2 (rigenerazione urbana)
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 6 (valorizzazione degli immobili di proprietà pubblica)
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 7 (procedure di Valutazione Ambientale)
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 10 (strumenti attuativi)
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 13
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 15 (attività estrattive)
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 16 (aree sviluppo industriale)
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 17 (edilizia agevolata)
canlı casino siteleri online casino rottbet giriş rott bet güncel giriş
Widgetized Section
Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone
Le periferie di Roma sono ancora periferie?
di Alfonso Pascale*
da Il Corviale, il giornale delle periferie
Quando s’immagina una metropoli la mente va dritta ad uno schema che si fonda sulla distinzione netta tra la città formale che costituisce il centro e, poi, una città parallela edificata per lo più in maniera casuale, schizofrenica, difforme, quasi un ammasso confuso come una marmellata. Il centro lo immaginiamo come il luogo della legalità, dell’ordine, della relazionalità e della cultura. Mentre la periferia la concepiamo come un magma orientato verso il centro per assumerne l’immagine e somigliargli. Il centro lo pensiamo come la residenza delle classi agiate. Mentre la periferia la idealizziamo come il luogo dove si affollano le classi subalterne, vogliose di emanciparsi e scardinare il recinto, il confine, la divisione.
Anche Roma la immaginiamo così. Chiunque, nei decenni scorsi, sia venuto da altre regioni ad abitare a Roma potrebbe identificarsi in Guido Corsalini, il protagonista del romanzo di Paolo Volponi La strada per Roma, quando giunse nella capitale la prima volta. Ancora sul treno, “egli vedeva le prime case, le prime vie che andavano a stendersi in larghi sterrati o che erano chiuse da argini di detriti”. Il convoglio si inoltrava nell’abitato e “mirava al centro, all’arrivo, a quella parte più nobile della città che sarebbe stata Roma per lui”. Dal finestrino “vedeva ruderi di mattoni e mentre guardava i monumenti trovò la città, distesa e alzata per quartieri interi, alti e stretti, larga larga, bagnata sotto gli alberi, riempita dalle sonagliere, dai vetri, dalle corse; la città grande, migliaia di finestre affacciate, gli spigoli che la squadravano, i cornicioni dei palazzi, i piani, le insegne, la polvere che si vedeva sotto il sole come se fosse essa stessa la terra; e i selciati, le aiuole fiorite, i giardini e i fiori appassiti che parevano messi, abbandonati ovunque, in ogni spiazzo e cantone. Il treno rallentava ed era ormai in mezzo alla rete dei binari”.
La contemporaneità dei tempi
Ma andiamo a guardare Roma attentamente con lo sguardo che tocca le cose, le modifica, le trasforma in parole, in immagini parlanti ed espressive, le distingue da sé e le fa vere. Se gli occhi guardano con amore, essi vedono. Non solo il luogo, ma il tempo: un luogo che è il tempo; il tempo che è un luogo. Ritroviamo così, nell’aspetto di Roma, le infinite particolarità di un grande mosaico, le innumerevoli vite quotidiane, le abitazioni nelle sue molteplici forme, le strade, le piazze, gli orti, gli alberi, le ricchezze, le miserie, i beni, i mali, le gioie, i dolori, la cronaca, i problemi, il tessuto dell’esistenza, tutto il multiforme e mutevole presente, tutta la memoria in un volto che tende tutto a somigliarci.
“Da lì, intorno, non si vedevano che tre o quattro cose. La distesa irregolare e immensa del prato con in fondo le sue barriere di case coi lumi tremolanti (palazzoni, da una parte, una distesa di casette dentellate coi muri a secco dall’altra); il cielo con qualche nuvola spennellata appena nel suo indaco profondo; la luna, in mezzo a quel cielo, che da rossa stava diventando di una luce fresca e purissima, con accanto, altrettanto luminosa la fedele piccola stella del crepuscolo. Tutto questo scenario – dove non c’erano sfumature, se non forse ai bordi del tratto fosforescente di cielo illuminato dalla luna – era riempito da un unico profondo odore, quello del finocchio selvatico. Tutto il cosmo era lì, in quel pratone, in quel cielo, in quegli orizzonti urbani appena visibili e in quell’inebriante odore di erba estiva”. Così Pier Paolo Pasolini descriveva nei primi anni settanta il pratone della Casilina, dove Carlo, il protagonista del romanzo incompiuto Petrolio, consuma un rapporto orale con venti ragazzi come in un ossessivo rituale del potere, ripetitivo e noioso. In quell’enorme spazio, tra l’Acquedotto Alessandrino e le baracche, c’era stato fino agli anni sessanta un campo di calcio dedicato al martire della Resistenza, Giordano Sangalli, che risiedeva nel quartiere di Tor Pignattara ed era stato ucciso dai soldati tedeschi a 17 anni. Era solita allenarsi in quel campo la mitica squadra “Chinotto Neri” arrivata in poco tempo a giocare in serie C. Fondate dai fratelli Neri, trasportatori di bibite e inventori della gustosa formula che fece il giro del mondo, l’impresa e la squadra erano fallite dopo un decennio di rapido successo. E il campo sportivo era tornato ad essere un prato impervio. Oggi c’è il parco Sangalli con l’area giochi per bambini frequentatissima dalle famiglie bengalesi, il circolo bocciofilo dedicato a Sandro Pertini e l’area cani. Ogni sabato si fa il mercato contadino, pieno di gente, e lo stato di desolazione descritto nelle opere pasoliniane è soltanto un ricordo.
Se andiamo a guardare la periferia romana con amore, noteremo con stupore che essa ha un volto che somiglia a noi stessi che la miriamo. Non c’è angolo di Roma, dentro e fuori il grande raccordo anulare, che non rimandi in qualche modo alla presenza degli antichi Romani e delle diverse comunità umane che nel tempo sono venute a insediarsi in questo territorio. La Roma delle origini accolse individui apolidi, nomadi, nobili decaduti e persino schiavi. Roma, si potrebbe dire, nacque come una città aperta non solo ai fuggitivi, ma agli uomini di coraggio, in cerca del nuovo, capaci di iniziative inedite. Dall’antichità ad oggi, Roma non ha mai cessato di essere una città capitale: di un grande impero e poi del mondo cristiano, di uno Stato ecclesiastico, infine dell’Italia unita. Si realizza nel territorio romano più che altrove una sorta di contemporaneità dei tempi. Tutto è avvenuto, tutto è nel presente. Scrive Carlo Levi parlando di Roma: “Ogni albero, ogni roccia, ogni fontana, contiene dentro di sé gli Dei più antichi: l’aria e la terra ne sono impastati e intrisi. Con gli Dei, gli uomini e i loro fatti: sui selciati delle strade, sugli asfalti delle automobili risuona l’eco di passi innumerevoli”.
La contemporaneità dei tempi non si manifesta solo nelle memorie antiche, nella diversa storia dei luoghi, ma nell’animo di ogni individuo, nell’avventura della sua vita particolare. Nei volti delle persone che vivono a Roma e le cui famiglie sono qui giunte da ogni contrada d’Italia e, ultimamente, da ogni paese del mondo, si può leggere una Roma contadina, umile come “humus”, umile di radici terrestri. È la Roma delle donne e degli uomini che dal 1870 vengono ad abitare in questo crogiuolo di fusione tra gente di varie regioni del paese. In questo senso Roma non è mai stata né tutta piemontese, né tutta meridionale, ma aperta ad influssi diversi. Nulla di questa singolare correlazione tra nucleo originario e apporti migratori, che connota già dall’inizio la Capitale, è rintracciabile in altra parte o città d’Italia.
Nel 1970 Franco Ferrarotti pubblica un libro ritenuto dissacrante fin nel titolo: “Roma da capitale a periferia”. Nel momento in cui si celebrava il centenario della “Breccia di Porta Pia” e la proclamazione della Capitale del nuovo Regno, il libro documentava il deperimento dell’idea e della realtà della Capitale, l’involuzione e lo scivolamento verso una posizione periferica, economicamente emarginata e politicamente, dal punto di vista europeo, insignificante. Non era una dissacrazione. Era un giudizio di fatto, legato ad una stagione cupa, quella di una falsa modernizzazione, di una modernizzazione tradita. Un caso di processo intenso di urbanizzazione senza industrializzazione e di una terziarizzazione spuria di tipo clientelare, usata dai partiti per garantirsi il consenso. Un caso di crescita demografica fortemente alimentata dall’immigrazione del resto del paese, sia come apporto diretto, sia come apporto indiretto dovuto ai figli degli immigrati. Al 1980 la popolazione residente nata fuori di Roma era 1 milione e 350 mila persone, mentre quella romana per nascita era di 1 milione e 600 mila e tra questa la maggioranza era data da figli di immigrati più o meno recenti. Un disagio enorme si accumula nel periodo del boom economico per l’arrivo impetuoso di immigrati senza che la città abbia la possibilità di offrire un lavoro a tutti. Di qui la contraddittorietà e il dinamismo che incominciano a legare, in quegli anni cruciali, i quartieri alti di Roma ai ghetti di miseria: tanti ragazzotti che servono nei bar del centro, tanti “cascherini” delle botteghe, tante donne che fanno la pulizia di notte negli uffici vengono dalle baraccopoli. Anche la burocrazia romana si diversifica: una parte rimane legalista e garantista, tendenzialmente conservatrice; l’altra è dinamica e funzionale, autentico braccio esecutivo dei grandi interessi economici dominanti. Ci sono immigrati che erano contadini scappati dalle campagne ammodernate della riforma agraria e, dunque, non più in grado di dare lavoro a tante braccia. E ci sono immigrati di lusso, collegati con la terziarizzazione della città. Le classi differenziali nelle scuole confermano duramente e sistematicamente le divisioni classiste, nonostante il carattere di massa assunto dalla scolarizzazione. La miseria e la degradazione urbana crescono con il crescere a dismisura della città. C’è una funzionalità nel meccanismo di crescita che in quegli anni sfata il mito di una urbanizzazione di per sé buona e armonica. È solo la paradossale coesistenza tra sottosviluppo cronico e iper-sviluppo consumistico. All’origine delle baraccopoli romane vi è dunque uno scarto oggettivo fra le esigenze del flusso di immigrati e la capacità della struttura economico- produttiva di farvi fronte. Uno scarto aggravato tragicamente dalla politica dei gruppi economici e politici dominanti che si è risolta in una resa incondizionata allo sviluppo spontaneo della situazione di fatto in base alle convenienze predatorie degli interessi prevalenti.
Né città né campagna
Oggi la situazione non è più questa. La “cintura rossa”, a suo tempo costituita da circa 70 mila operai dell’edilizia, non esiste più. È stata distrutta dalla nuova immigrazione extra-comunitaria e dalle innovazioni tecnologiche e produttive delle grandi imprese edili, che hanno soppiantato e spinto fuori mercato i “palazzinari”, grandi e piccoli, con la divisione del lavoro, la specializzazione delle mansioni produttive, i nuovi materiali e le nuove tecniche del processo produttivo. Il ghetto edile non c’è più. Non ci sono più le baracche dove si dovrebbero trovare gli attrezzi agricoli elementari: oggi vi dormono , un tanto a letto, gli extra-comunitari. Nei quartieri periferici c’è una riduzione significativa di quella che resta la caratteristica fondamentale di tutte le periferie, cioè l’esclusione sociale e la discriminazione classista. Centro e periferie non sono più realtà insanabilmente divise, estranee l’una all’altra, come città e anticittà.
Ogni discorso sulla periferia del futuro non può più partire da un’idea generica di periferia che si contrappone al centro. Questa realtà a Roma non esiste più. Non c’è più campagna e non c’è più città ma un continuum urbano-rurale. Quarant’anni fa, con una popolazione complessiva di circa tre milioni di abitanti, si ipotizzava, per il 2003, una popolazione complessiva di circa tre milioni di abitanti. Roma ha registrato invece una diminuzione della popolazione residente e conta circa due milioni ottocentomila abitanti. Si è verificato un controesodo dal centro verso l’esterno, dentro e fuori il grande raccordo anulare. C’è stato un afflusso di fasce consistenti di ceto medio con redditi medio-alti che ha provocato un abusivismo di lusso e che può vivere e svilupparsi a porta a porta con l’abusivismo dei disperati. Nello stesso tempo, l’intera area metropolitana è diventata meta di un’ulteriore ondata di immigrazione dalle zone più periferiche del paese, nonché dal Sud del mondo, dedita in primo luogo ai lavori nocivi per la salute, scarsamente remunerati e di poco prestigio, rifiutati dai lavoratori indigeni. I nuovi arrivati dalle aree rurali più interne, insieme agli immigrati di altri Paesi, sono andati ad abitare in quelle estese porzioni di territorio in cui – già dagli anni ’70 − convivono permanentemente sia i caratteri tipici dell’urbanità, come la prevalenza dell’edificato sull’open space, che i caratteri tipici delle aree rurali, come la presenza di attività non solo agricole che si collegano al patrimonio culturale e paesaggistico dei luoghi di riferimento. In questi territori si sono addensate negli ultimi quarant’anni non solo le “villettopoli” di famiglie benestanti, ma anche le abitazioni di persone che rifuggivano l’impazzimento delle città e hanno ricercato in nuove attività agricole e rurali una chance per dare un senso alla propria esistenza. A cui si sono aggiunte recentemente le abitazioni a basso costo dei nuovi arrivati dalle zone più interne e dei nuovi poveri. Questi sono attualmente i ceti sociali coinvolti in quel fenomeno descritto per la prima volta nel 1976 da Gerard Bauer e Jean-Michel Roux con un neologismo non troppo elegante ma perspicuo: “rurbanizzazione”, vale a dire la congiunzione di rus, campagna, e urbs, città. Ciò significa che la periferia non è più periferica e che il centro non ha da decentrarsi, pena il soffocamento, il declino e la morte. Bisognerebbe riscoprire lo stile del costruire, tipicamente mediterraneo, fondato su un concetto di natura non nemica, bensì collaboratrice. Scrive Carlo Cattaneo: “La lingua tedesca chiama con una medesima voce l’arte di edificare e l’arte di coltivare; il nome dell’agricoltura (Ackerbau) non suona coltivazione, ma costruzione; il colono è un edificatore (Bauer). Quando le ignare tribù germaniche videro all’ombra dell’aquile romane edificarsi i ponti, le vie, le mura, e con poco dissimile fatica tramutarsi in vigneti le vergini riviere del Reno e della Mosella, esse abbracciarono tutte quelle opere con un solo nome. Sì, un popolo deve edificare i suoi campi, come le sue città”. Roma dovrebbe essere ripensata concependo i territori urbani come ecosistemi e come comunità epistemiche che elaborano concezioni condivise dell’alimentazione, della salute, della cultura, della sicurezza, del rapporto da intrattenere con il verde, e “costruiscono-coltivano” filiere produttive, modalità di abitare e forme di mobilità sostenibili. E questo può avvenire perché non è più la capitale che rischia di andare a tramutarsi in periferia. È una periferia che faticosamente, ma caparbiamente, cerca di farsi capitale.
L’immigrazione extra-comunitaria
La prima ondata delle immigrazioni extra-comunitarie, quella degli immigrati che dall’Africa e dal Medio Oriente, dalle Filippine e dallo Sri-Lanka, da soli e con evidente spirito d’avventura e di sacrificio, hanno sfidato le incertezze di paesi stranieri e di nuove, sconosciute culture, si è esaurita da un pezzo. È iniziata da tempo la seconda ondata. Ai pionieri si sono unite le famiglie. Le mogli e i figli richiedono misure più complesse del mero lavoro: non solo l’abitazione, ma la scuola, le cure mediche, e quindi l’ospedale, i luoghi non solo di riunione ma anche di culto.
La prima generazione punta sui mezzi elementari di sopravvivenza, va al sodo, cerca di adattarsi, di dimenticare le radici – ciò che è peraltro impossibile – di cambiare addirittura il nome, come atto di suprema gratitudine al Paese ospitante, anche se poi sovente accade che l’immigrato, rinunciando alla propria cultura, non venga accettato dalla cultura del Paese ospitante, e si trovi così nel limbo di un deserto privo di valori certi, a mezza parete, sospeso fra una cultura e l’altra. I figli, però non tardano a vedere negli atteggiamenti del padre una sorta di tradimento della cultura d’origine, tornano spasmodicamente a ricercare e a rivalutare le proprie radici, scorgono nell’atteggiamento del padre solo un ricatto da parte del paese ricco, un ricatto da lavarsi col sangue e col fuoco.
La seconda e la terza generazione vedono i padri ricattati per fame dal paese ospitante, lamentano la loro cultura originaria nei corsi scolastici, si sentono discriminati nell’abitazione, nel lavoro. Non basta un passaporto o qualsiasi altro documento giuridico a fare un cittadino in senso pieno. Riscoprono le loro antiche radici, la loro lingua, la cultura tradita dai padri. E questo atteggiamento fa emergere i limiti del concetto di integrazione, inteso come assimilazione e omologazione, e porta ad un ampliamento della nozione originaria di multiculturalismo e ad una rielaborazione dei diritti culturali.
Un diritto culturale è per esempio una norma che consente ai negozianti di religione musulmana di svolgere la loro attività commerciale in accordo con le loro pratiche religiose. Un altro diritto culturale è la facoltà concessa ai gruppi che aderiscono a determinate credenze religiose o filosofiche di adottare il metodo dell’agricoltura biodinamica nell’ambito di specifiche regole che, comunque, devono tutelare i diritti dei consumatori. Si tratta di soluzioni di prudenza poiché, se il diritto individuale è fondamentale, e deve restarlo, gli accomodamenti avvengono su questioni che non sono essenziali per lo stato di diritto.
È possibile avere un’ampia politica di diritti culturali, ma la decisione sulla sua ampiezza dovrebbe essere presa dalle istituzioni, non dal gruppo culturale che la sostiene, tenendo ferma la difesa dei diritti individuali, i quali non sono sempre in armonia con le difesa del gruppo che rivendica politiche culturali rispettose della propria identità.
Mentre i diritti civili non sono negoziabili, le politiche culturali lo sono, e per questo possono sempre essere revocate. Il multiculturalismo deve favorire il rispetto del pluralismo ma non deve portare mai all’affossamento dello stato di diritto e al ripristino dello stato corporativo. Sarebbe un pericolo per la democrazia se gruppi etnici o portatori di particolari sensibilità culturali rivendicassero una propria specificità contro la generalità dei cittadini e contro altri gruppi, chiedendo che la politica segua l’identità e che la legge si modelli sull’identità più rappresentativa o maggioritaria su di un territorio. Tale pericolo emerge quando i gruppi si auto-rappresentano non tanto o non solo come diversi, ma come meritevoli di un potere o di una considerazione superiori a quelli di altri gruppi.
Le istituzioni pubbliche sono di tutti e, quindi, non devono assolutamente far proprie convinzioni etiche e religiose o che attengano a specifiche visioni culturali, modelli produttivi e di consumo che sono di qualcuno e che divergono con quelle di qualcun altro. Se ne deve tener conto in via prudenziale, ma salvaguardando sempre i diritti individuali di coloro che non aderiscono a quelle credenze.
Una nuova laicità
È questa la laicità pubblica del XXI secolo da realizzare con istituzioni pubbliche che devono rimanere neutrali per non degenerare in istituzioni non democratiche. Dovrebbe essere preoccupazione di tutti coloro a cui sta a cuore l’eguale libertà democratica di cittadinanza difendere le istituzioni dal morbo che conduce alla perdita della laicità, imparzialità, neutralità pubblica. Democrazia e laicità, simul stabunt, simul cadent. Non bisogna avere remore nel criticare deliberazioni e scelte istituzionali che, riflettendo gli interessi di gruppi politici che mirano a soddisfare domande di eticità di frazioni di popolazione, ledono l’eguale rispetto dovuto a chiunque, in quanto cittadino o cittadina di pari dignità nella polis.
È inevitabile che la globalizzazione renda più intense le domande sociali di identità rivolte al sistema politico democratico e incentivi la presentazione conflittuale, nell’arena istituzionale, di domande di eticità. E che un’autorità politica che perde colpi rispetto a poteri sociali come la finanza, l’economia e la comunicazione, si rivalga soddisfacendo la domanda di eticità.
D’altra parte, anche il persistere della crisi economica e sociale crea un nesso molto forte tra questioni di identità e questioni di giustizia distributiva o di equità sociale. Ma queste ultime non sono separabili dalle altre, in quanto nascono intimamente unite alle prime. E tuttavia, né la globalizzazione né la crisi economica né il malessere sociale che ne consegue possono farci smarrire che la democrazia sia un valore irrinunciabile che non può essere mediato con altri.
Sappiamo che non c’è valore che non sia esposto al rischio della sua perdita e dissipazione. E oggi le derive populistiche, gerarchiche e plebiscitarie dei regimi democratici sono alimentate anche dalle continue risposte che le autorità pubbliche danno alle domande di eticità. Va tutelato il diritto di assicurare ai gruppi specifici di esprimere i propri punti di vista sulle politiche pubbliche. Perché solo l’esercizio di questo diritto permette il dibattito pubblico, non istituzionale, delle diverse opzioni ai fini della condivisione e contaminazione e, dunque, dell’interculturalità. Ma questo diritto va sempre accompagnato dall’eguale rispetto dovuto a chiunque non malgrado, bensì in virtù delle differenze e delle distinte concezioni di valore, etico, religioso e culturale.
In una società che fa perno sulla Costituzione e sugli eguali diritti, nessuna identità è di per sé più potente di un’altra. D’altra parte i totalitarismi sono identitari perché mirano a creare società non di diritto ma di sostanziale identità. C’è un nesso molto stretto tra democrazie identitarie e degenerazioni xenofobe e razziste. È quello che, purtroppo, avviene nelle periferie romane, dove si formano spontaneamente quartieri multietnici. Le due cose non sono necessariamente concatenate come causa ed effetto. Ma i rischi sono altissimi perché nella cultura europea c’è una resistenza molto forte al pluralismo e un’acquiescenza molto estesa al centralismo e all’omologazione. In alcuni quartieri di Roma, come Torpignattara e Pigneto, stanno proliferando nuove forme di mafia per iniziativa di organizzazioni criminali, dedite al traffico di droga e al riciclaggio di denaro sporco, che strumentalizzano l’identità e il disagio sociale indotto dalla difficoltà di interazione tra le diverse etnie che convivono senza efficaci politiche di integrazione. Per affrontare questa nuova situazione è necessario affermare una cultura della legalità e fare in modo che le culture identitarie dialoghino, interagiscano senza mai proporsi al di sopra della cultura dell’eguaglianza e della dignità della persona. Non ci può essere un’eguaglianza all’interno di un gruppo diversa dall’eguaglianza praticata in un altro gruppo perché una simile concezione comporta negare l’eguaglianza come principio di relazione tra diversi. E queste considerazioni valgono per tutti i gruppi, sia quelli autoctoni che per quelli di immigrati.
Identità e universalità dei diritti per un nuovo comunitarismo
I contesti e i gruppi specifici costituiscono un’opportunità per rivitalizzare e arricchire nuove forme di società civile che correggano l’individualismo. E tuttavia bisogna tendere a costruire legami sociali che promuovano comunità-territorio aperte a tutti e che decidano con la regola di una testa un voto. È in tal modo che si può andare oltre la solidarietà e si può affermare la fraternità civile. Le comunità-territorio contemporanee devono saper cogliere le opportunità della globalizzazione e non chiudersi in sé stesse. Bisognerebbe accompagnarle ad acquisire la capacità di auto-rappresentarsi e di costruire la propria immagine. Ma tale capacità presuppone una chiara percezione di sé, per fare in modo che gli scambi culturali ed economici con altre comunità-territorio del mondo globale siano reciprocamente arricchenti e improntati ad una relazionalità collaborativa.
Di qui l’importanza di studiare e conoscere scientificamente i contesti in cui fioriscono le vite delle persone e dei gruppi mediante approcci interdisciplinari e un’attività permanente di ricerca-azione finalizzata a promuovere percorsi partecipativi progettuali per lo sviluppo locale. Le storie di vita, le memorie delle persone e dei beni strumentali, architettonici, archeologici e paesaggistico-ambientali sono elementi indispensabili per fare in modo che gli individui e i gruppi si approprino delle loro radici e di un’identità consapevole e capace di aprirsi ad altre identità.
I contesti vanno vissuti da persone che comprendano i processi e i meccanismi con cui questi si producono. Le comunità-territorio contemporanee devono servire prioritariamente a siffatto scopo. Solo con un forte senso di sé e stabilendo regole democratiche condivise per il proprio funzionamento nei percorsi partecipativi dal basso, le comunità-territorio possono svolgere una funzione propulsiva, alimentando valori da immettere nelle istituzioni e nel mercato. Per farlo devono essere comunità che non pongono in alternativa l’appartenenza identitaria e l’universalismo dei diritti. L’individualismo si corregge con un nuovo comunitarismo che non mette in discussione i diritti individuali. Altrimenti, coniugandosi in modo distorto con le culture identitarie, l’individualismo porta inevitabilmente alla violenza e alla sopraffazione.
Le nuove povertà
Le periferie di Roma sono anche scenari di nuove forme di povertà. Fino a poco tempo fa, essere povero voleva dire essere disoccupato. Oggi la condizione di povertà coincide con la mancanza di prospettive per superare la povertà stessa, con orizzonti che progressivamente si chiudono sempre di più. Fino a poco tempo fa, la povertà era sentita come un onere collettivo, come un fronte su cui convergeva l’impegno civile e politico. Oggi è sempre più facile che la reazione comune sia invece quella di lasciare solo l’insegnante o l’artigiano che si è impoverito, la madre con un figlio minore dopo la separazione da un coniuge violento, il cinquantenne che ha perso il lavoro e che non è riuscito a integrarsi, l’ex detenuto che non trova un’occupazione perché nessuno lo vuole, l’anziano che non ha la possibilità di mantenere un badante, l’immigrato irregolare. Oggi la reazione prevalente è quella di adottare comportamenti e politiche tesi a difendere i privilegi di chi è integrato nel sistema e ne accetta le regole. In termini di scelte concrete, questo ha comportato la opzione di far arretrare la linea di protezione del welfare, accentuando la solitudine e la marginalizzazione di chi si trova a vivere fuori dagli schemi, sempre più “senza rete”.
Se si vanno a scorrere alcune storie di vita raccolte negli ultimi anni sui marciapiedi di Roma, raramente le nuove povertà sono determinate da un evento traumatico che altera all’improvviso un equilibrio. Spesso si tratta dell’aggravamento complessivo di una condizione individuale o familiare dovuta a fallimenti nelle strategie esistenziali che si cumulano nel tempo. C’è un confine che delimita lo stato di povertà con quello di indigenza e viene definito “linea della povertà”. Chi sta al di sopra ha mezzi sufficienti per vivere degnamente; ma solo in via eccezionale può soddisfare spese straordinarie o consumi non strettamente necessari al sostentamento. Il nuovo povero è colui che vive costantemente con la paura di non farcela e di scendere al di sotto della linea della povertà. L’indigente è, invece, colui che vive in una condizione di bisogno non occasionale, ma continuativo nel tempo. Egli e la sua famiglia devono operare continue transazioni fra beni, pur necessari, ma che non possono essere acquisiti tutti insieme. Al di sotto dell’indigenza, troviamo la miseria. In questo caso, l’espediente diviene il mezzo quotidiano di sussistenza. Le prospettive di vita si restringono drammaticamente. Se ancora c’è, il nucleo familiare va rapidamente verso la disgregazione. La miseria si autoriproduce e diviene una condizione o stile di vita. Ci sono poveri cui non importa di essere poveri. Accettano la povertà. La scelgono come modo di vita. Rinunciano all’Iva e al codice fiscale. Non ricevono bollette né per la luce né per il gas, permesso di circolazione, tanto meno per radio e TV. E da vittime, le persone che versano in una condizione di miseria vengono fatte passare per responsabili. La loro è una condizione “senza rete”, di privazione e di emarginazione, che tanto più colpisce quanto più coincide con la vita per strada, un luogo che invece tutti frequentiamo ogni giorno, pieno di vita, di rumore, di luci, di consumi, di socialità.
La vita per strada è una vita che si svolge al di fuori del sistema e non riesce a comunicare con le reti dei servizi sociali locali. In Italia, per avere assistenza, bisogna richiederla. L’utente potenziale del servizio sociale è considerato un individuo razionale, volterriano, e non un individuo che ha un profondo senso di sé e nasconde la propria condizione perché ne prova vergogna e così non intende avvalersi di un proprio diritto. Quando si oltrepassa la soglia dell’incapacità-riluttanza a provvedere a se stessi si attenta direttamente alla propria vita. Ma non per questo, quell’individuo non ha diritto di essere aiutato. Se è così, allora non si può mettere sullo stesso piano un cittadino che richiede l’allaccio di un’utenza qualsiasi (acqua, elettricità, gas, telefono, ecc.) con un cittadino che invece richiede, quando è in grado di farlo, una prestazione di tipo socio-assistenziale, come se le due tipologie di servizio fossero immediatamente equiparabili. Non si comprende che non esiste più una modalità univoca per definire povertà e bisogno. Riemerge, invece, nella contemporaneità, una categoria propria del mondo rurale che Ernesto De Martino definiva “crisi della presenza”. Essa veniva reintegrata ritualmente attraverso pratiche collettive che ponevano il soggetto al centro di un ambito relazionale concluso e culturalmente condiviso. L’individuo era parte di un tutto. Oggi, a una progressiva individualizzazione, corrisponde un processo di desocializzazione. Solo le pratiche comunitarie sono in grado di offrire alle povertà estreme una gestione collettiva della crisi della presenza.
Il codice sorgente dell’italicità
Scrive Renzo Piano: “bisogna che le periferie diventino città, ma senza ampliarsi a macchia d’olio, bisogna cucirle e fertilizzarle con delle strutture pubbliche. Si deve mettere un limite alla crescita, anche perché diventa economicamente insostenibile portare i trasporti pubblici e raccogliere la spazzatura sempre più lontano”. Mi sembra una ricetta ancora insufficiente e ancorata all’ambito dell’architettura priva di una visione olistica. Roma dovrebbe finalmente fare i conti coi temi dello sviluppo economico. Essa ha conosciuto essenzialmente l’industria edile e poi la superfetazione delle burocrazie statali e regionali. Non ha mai conosciuto un vero e proprio sviluppo industriale.
Gli altri paesi avanzati, a partire dagli Stati Uniti, cercano di uscire lentamente dalla crisi economica innescando una nuova fase dello sviluppo industriale fondato su internet e sulla robotica e, naturalmente, su una trasformazione totale del lavoro sia dipendente che imprenditoriale e su forme totalmente nuove dell’abitare. In Italia, invece, non parliamo più di sviluppo industriale come se la fine del fordismo abbia significato la fine dell’industria e non parliamo più dell’abitare come se l’unica possibilità che abbiamo dopo la cementificazione selvaggia delle aree agricole sia solo quella di adattarci a vivere nel “già costruito”. La rivoluzione tecnologica in atto può aprire una nuova prospettiva allo sviluppo dei territori e dei mercati internazionali in cui l’agricoltura e l’agroalimentare, i beni culturali e paesaggistici, l’artigianato artistico e le attività turistiche possono diventare elementi qualificanti e partecipare attivamente con l’insieme dell’economia al salto tecnologico che si sta realizzando. Ma si tratta di innescare uno sviluppo industriale di tipo nuovo, legato alle risorse locali e all’ingegno umano, alle comunità-territorio e all’internazionalizzazione. Uno sviluppo industriale fondato su una rivoluzione tecnologica che si accompagna ad una nuova visione dell’abitare. Non è più dinanzi a noi la metropoli fordista. Ma qualcosa che è impossibile programmare, pianificare e gestire con gli strumenti amministrativi utilizzati finora. Occorrerebbero percorsi di progettazione ad alta risoluzione capaci di mobilitare le comunità locali, cioè i soggetti e i gruppi che le compongono, senza più separarli per categorie. Anche i luoghi dell’abitare non sono più spazi chiusi, ma ogni edificio o spazio tende a trasformarsi in luogo polivalente, inglobando diverse funzioni nel legarsi ad altri edifici e ad altri spazi.
Per ricostituire le comunità-territorio e per fare in modo che queste possano meglio cogliere le opportunità della globalizzazione, bisognerebbe accompagnarle nell’acquisire una chiara percezione di sé, per fare in modo che gli scambi culturali ed economici con altre comunità-territorio del mondo globale siano reciprocamente arricchenti e improntati ad una relazionalità collaborativa. Le arti e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione possono alimentare la capacità delle reti locali di costruire in modo creativo la propria immagine e di riscoprire il Genius loci come processo culturale di autocoscienza e di apertura agli altri.
L’identità di una nazione è caratterizzata da due importanti aspetti che i nazionalismi, vecchi e nuovi, tendono a oscurare. Il primo è che oggi l’identità nazionale è sempre più frutto di una scelta volontaria di persone e imprese che aderiscono a valori, stili di vita, modelli di business che contribuiscono a costruire un futuro possibile, non solo ereditare una storia passata. Il secondo è che le identità nazionali hanno sempre più natura plurale, nel senso che le appartenenze non si escludono in base al territorio in cui si risiede, ma si possono combinare in rapporto a volontà e capacità di far convivere più dimensioni dell’esistenza. Ad esempio, possiamo sentirci orgogliosi delle nostre tradizioni romane, senza che questo escluda di riconoscerci come italiani ed europei. Ma ciò vale anche per un oriundo argentino, per un newyorchese discendente di migranti italiani o per chi vive nel Canton Ticino. Lo stesso per chi essendo nato in qualsiasi altra parte al mondo ha poi deciso di vivere in Italia o è stato attratto dalla cultura, dalla storia, dal paesaggio o dalla lingua del nostro Paese. Questo modo di guardare all’identità nazionale può avere per l’Italia conseguenze politiche ed economiche rilevanti. Infatti, se ai 60 milioni di italiani aggiungiamo gli emigrati italiani e i loro discendenti, e poi chi ha scelto l’Italia come patria o l’italiano come lingua, si superano i 250 milioni di persone. Pochi altri Paesi al mondo possono vantare un rapporto così elevato fra diaspora (gli italici nel mondo) e cittadini residenti (gli italiani in patria).
Ha senso, dunque, fare una guerra commerciale all’italian sounding, cioè all’impiego di nomi su prodotti che richiamano il made in Italy senza esserlo, come il Parmesan? Una guerra commerciale destinata ad essere persa perché non ci sarà nessun tribunale internazionale disposto a sostenere le nostre ragioni. Non ci converrebbe, invece, sfruttare in positivo la notorietà mondiale che l’originale può ricevere dai tentativi di imitazione? È davvero utile e producente ostacolare la “fuga dei cervelli”? Non ci sarà nessun decreto che potrà proibire ad un giovane di andare a lavorare dove meglio lo aggrada. Non ci converrebbe, invece, sostenere la circolazione internazionale dei nostri giovani talenti per favorire l’estensione della cultura e dell’economia italiana nel mondo?
Affinché ciò possa avere successo è, tuttavia, necessario sviluppare il “codice sorgente” dell’italicità, costituito da quell’universalità culturale che, grazie alla ricca varietà di ambienti e città della penisola, a partire dalla Capitale, nonché alle contaminazioni che hanno segnato la nostra storia, ha reso possibile accumulare uno straordinario patrimonio di arte, cultura materiale, capacità manifatturiere che il mondo ci invidia. Si tratta di ridisegnare completamente il rapporto tra territori e mercati internazionali mediante politiche industriali per l’internazionalizzazione fondate sul “fare squadra” in Italia e all’estero, sulla nostra capacità – da sempre dimostrata nella nostra storia – di favorire processi di interscambio culturale prima ancora che commerciale, sulla costruzione di reti diffuse e collaborative tra pubblico e privato (a partire dai territori con più antiche tradizioni di sviluppo locale) e sul rendiconto alle comunità territoriali dei risultati conseguiti. Roma Capitale potrà scommettere sul suo futuro se farà scelte coraggiose d’investimento nel nuovo scenario che la globalizzazione apre dinanzi a noi.
* Alfonso Pascale, dopo una lunga esperienza di direzione nelle organizzazioni di rappresentanza dell’agricoltura ho promosso con altri l’Associazione “Rete Fattorie Sociali”, di cui è presidente. Membro del comitato di redazione della rivista culturale “l’albatros”, collabora con “Le nuove ragioni del Socialismo”, “MondOperaio”, “Decanter”, “Ragioni Socialiste”, “La Rivista di Servizio Sociale”, “La Questione Agraria”, “L’Informatore agrario” e le riviste on line “Agriregionieuropa” e “Teatro Naturale”. > Alfonso Pascale