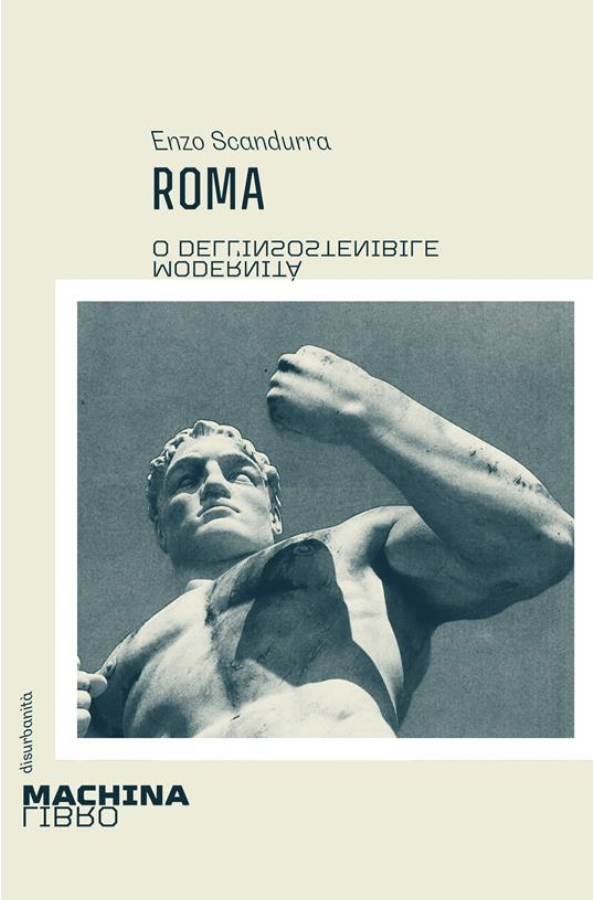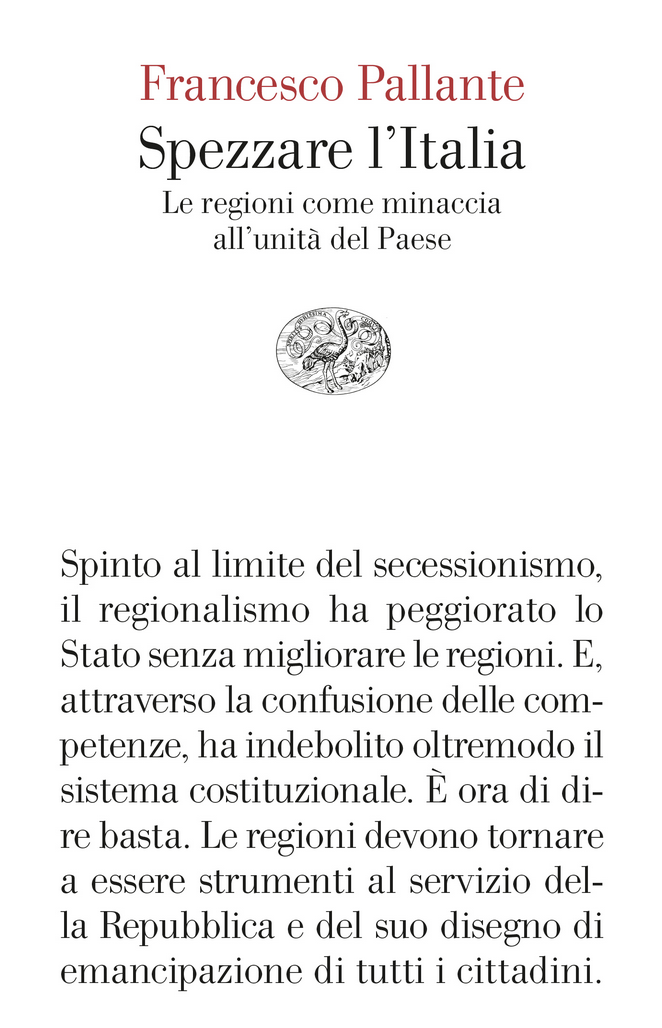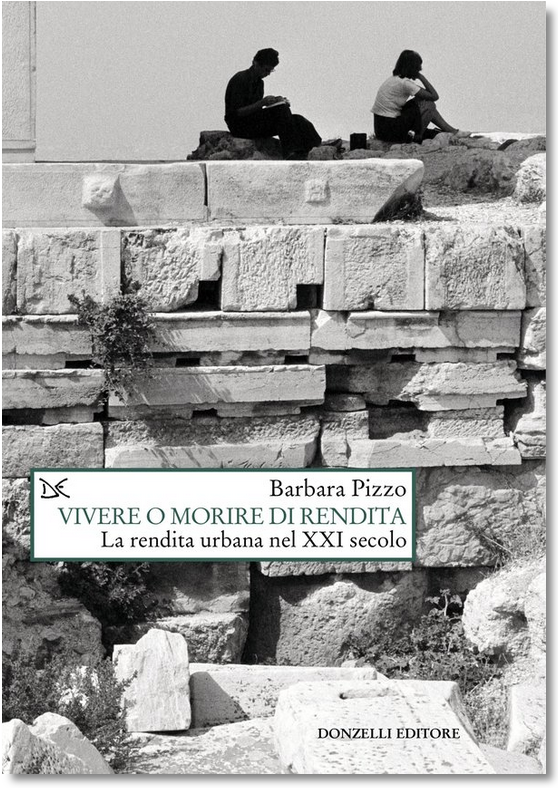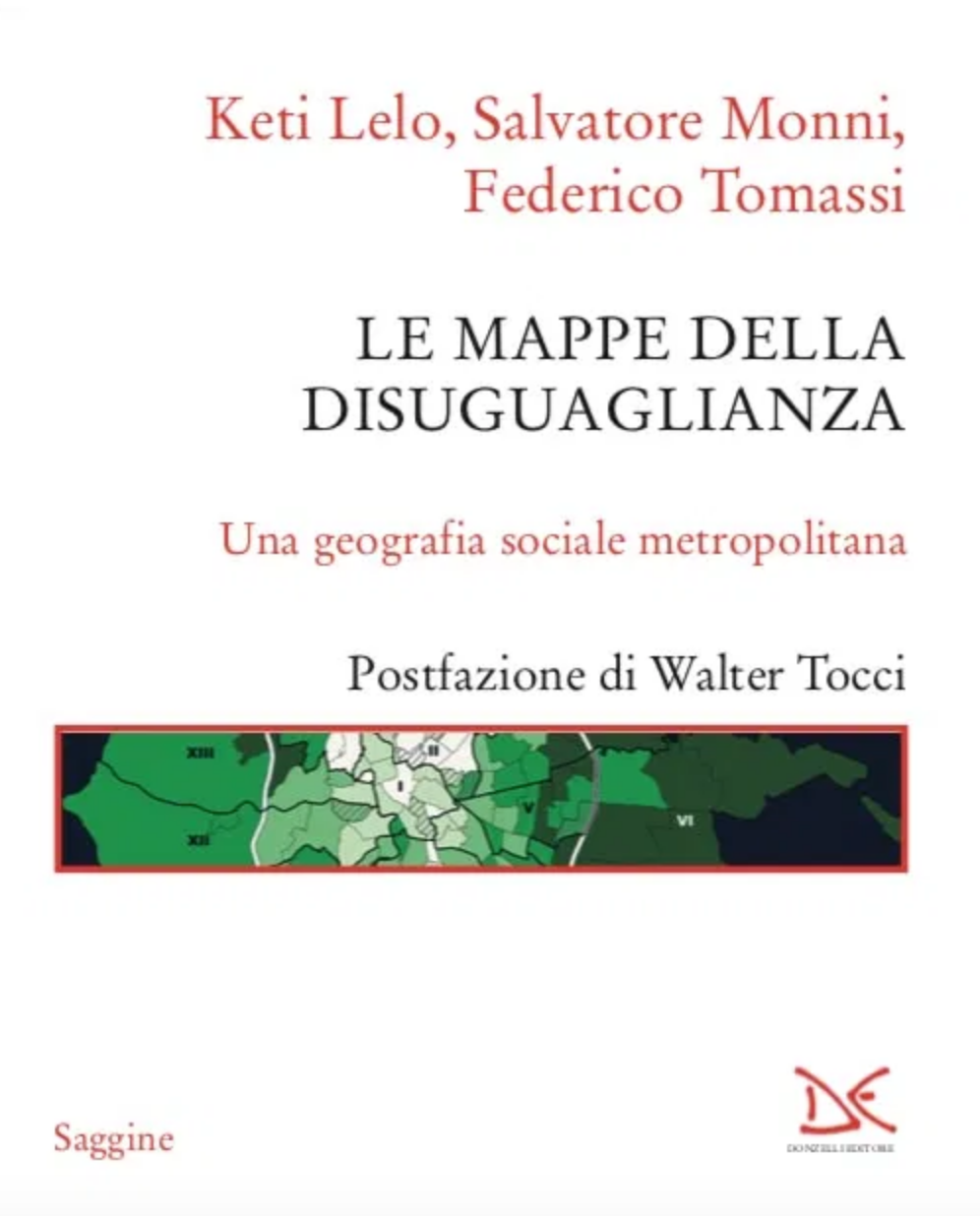Diverso tempo fa giravo in bicicletta per uno dei quartieri ‘dormitorio’ della periferia romana, un’urbanizzazione ‘monstre’ caratterizzata quasi esclusivamente da palazzoni anonimi e del tutto priva di spazi per la socialità. Ragionando, come sono solito fare, di rigenerazioni urbane, ho provato ad immaginare la pedonalizzazione di una piazzetta, attualmente destinata a parcheggio. La piazza era questa.

Stavo già iniziando a sostituire, nella mia testa, la pavimentazione in asfalto con un mattonato, i parcheggi con tavoli e sedie, quando ho volto lo sguardo in alto ed ho visto uno spettacolo che, come una doccia fredda, ha gelato le mie fantasie.

“Che persone possono vivere in questi edifici?”, mi sono domandato. O meglio, che persone possono vivere in questi edifici, all’interno di questo particolare quartiere privo di tutto, per decenni? Siamo sicuri che queste persone vorrebbe realmente una piazza pedonale, uno spazio vivibile, quando non ne hanno sentito la necessità per così tanto tempo? Quando hanno scientemente scelto di vivere in uno spazio tanto alieno alla socialità? Siamo sicuri che questa ipotetica piazza la vivrebbero come una ricchezza e non come un fastidio?
Negli anni passati la città di Roma ha provato a realizzare diverse pedonalizzazioni. Una tra le più famose (o famigerate) è quella del quartiere Pigneto. Un lavoro sicuramente ben fatto, ma che a posteriori ha generato parecchio scontento. La principale preoccupazione dei residenti è che il viale pedonale sia diventato, in breve tempo, una piazza di spaccio.

Situazione analoga si sta presentando nel quartiere San Lorenzo, oggetto di recenti fatti di cronaca nera sempre legati al mercato delle sostanze stupefacenti, dove la stessa problematica è stata sollevata per Piazza dell’Immacolata. È, indubbiamente, un problema che non va sottovalutato, e che pone diverse questioni importanti: di chi è lo spazio pubblico, chi lo controlla, chi ne fruisce? Apparentemente non i residenti, al punto che, abbandonati a se stessi, questi spazi non presidiati diventano zone franche per varie forme di degrado, dalle risse allo spaccio.
In un famoso racconto, Dino Buzzati ragiona sulla libertà. Riassumendo in breve, la storia narra di un pesciolino rosso che vive in una boccia di vetro. Il proprietario pensa allora di concedergli una maggiore felicità realizzando una grande vasca, quindi colloca la boccia di vetro sul fondo e aspetta che il suo pesciolino si goda la libertà di sguazzare finalmente in lungo e in largo. Invece il pesciolino finisce col preferire lo starsene rintanato nella sua boccia ed accontentarsi dell’idea di libertà, temendo che l’approfittarne finisca col tradursi in assuefazione, e quindi nel desiderio di una libertà ancor maggiore, alla quale non potrà mai permettersi di aspirare.
In realtà quello del pesciolino rosso di Buzzati è un alibi per rifiutare una libertà che sostanzialmente non desidera, e della quale non sa che farsene. Una scusa per rinchiudersi nel suo guscio di vetro ed evitare di misurarsi col mondo e con la vita, in tutta la sua fatica e bellezza. Ma quanti dei nostri concittadini vivono questa stessa ‘sindrome del pesce rosso’? E soprattutto, quanto tempo è necessario perché una sistemazione urbana diventi efficace attraverso il ricambio, generazionale se non mentale, delle persone che vivono in prossimità?
Osservata in prospettiva, l’urbanizzazione demenziale perpetrata a tappeto su un arco temporale di decenni ha prodotto una umanità alienata e disabituata alla socialità, condizione per altri versi funzionale ad un modello consumistico dell’esistenza. Popolazioni di provenienza rurale, abituate alle relazioni sociali (senza andare troppo lontano, penso ai miei genitori), si sono ritrovate intrappolate in un contesto urbano disfunzionale, che sul lungo periodo ne ha prodotto un’involuzione antropologica permanente, fissata definitivamente nelle generazioni successive. Esattamente quella preconizzata nei lontani anni ’70 da Pier Paolo Pasolini, che in un famoso video girato a Sabaudia concludeva amareggiato: “…e ora non c’è più nulla da fare!”
Quindi cosa possiamo legittimamente attenderci dal tentativo di reintrodurre spazi di socialità in contesti urbani che ne sono stati tanto a lungo privi? In primo luogo una sostanziale riluttanza, da parte di chi non li ha mai vissuti, né di fondo desiderati, ad occuparli. O forse li ha desiderati, ma quando questi si materializzano si scontra con la propria sostanziale incapacità di fruirne, esattamente come il pesce rosso. Sogniamo le piazze dei paesi, dove ci si ritrova la sera per chiacchierare, ma quando le mettiamo in pratica sotto casa nostra ci accorgiamo che non abbiamo nessuno con cui ci vada di chiacchierare, e il più delle volte che di chiacchierare non ne abbiamo nemmeno voglia, preferendo imbambolarci davanti ad uno schermo televisivo.
Ad aggravare la situazione c’è l’abitudine tutta italiana a vivere in case di proprietà, che rallenta il ricambio delle popolazioni. Se negli altri paesi possiamo attenderci che una sistemazione urbana pedonale finisca con l’attrarre, in tempi ragionevoli, una fetta di abitanti interessata a fruirne, nella realtà italiana ci scontreremo con dei residenti del tutto non interessati a muoversi altrove e lasciare quegli spazi, ma che anzi combatteranno attivamente per riottenere quelli che considerano dei ‘benefit’, come la possibilità di parcheggiare gratuitamente sotto casa.
Non mi piace lasciarvi con l’ennesima conclusione pessimista. Quello che ispira le mie riflessioni è di fondo l’esigenza di inquadrare correttamente i problemi nella loro complessità, onde evitare di realizzare interventi destinati a fallire proprio per la scarsa comprensione delle dinamiche ad essi correlate. Purtroppo, più vado avanti ad analizzare, più problemi emergono. E vieppiù mi convinco che la realtà in cui viviamo, se non il peggiore dei mondi possibili, resta quella più coerente con il cumularsi di miserie ed errori, ormai difficilmente reversibili, commessi nel tempo dalle generazioni che si sono susseguite.