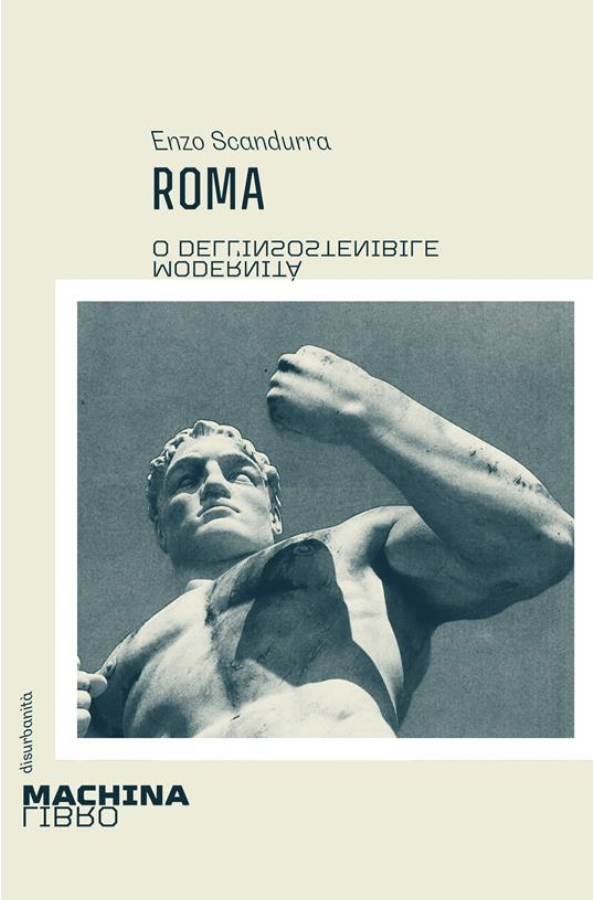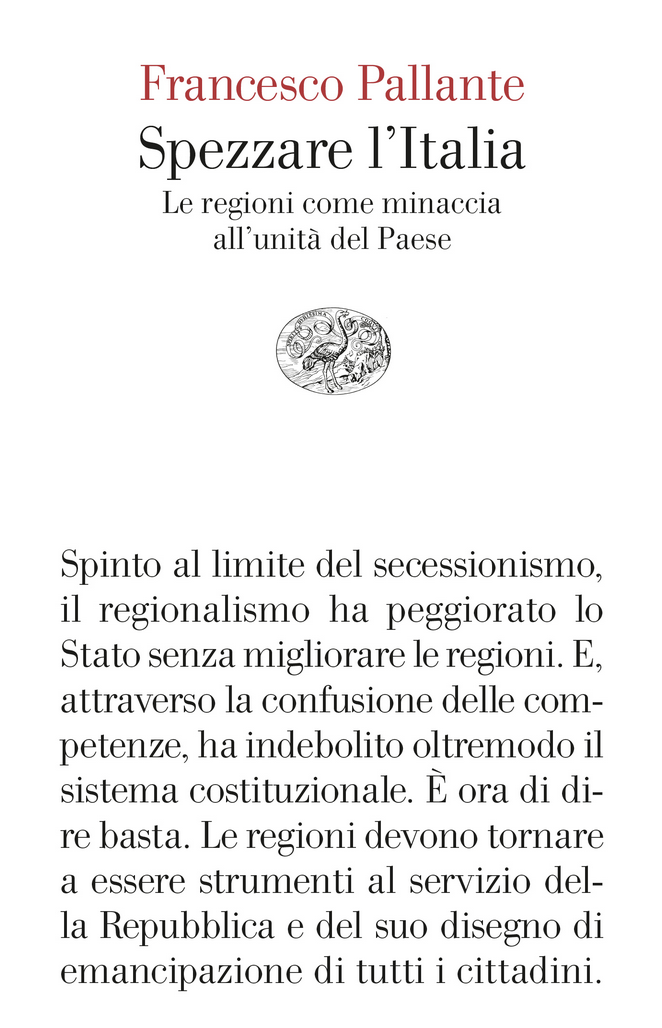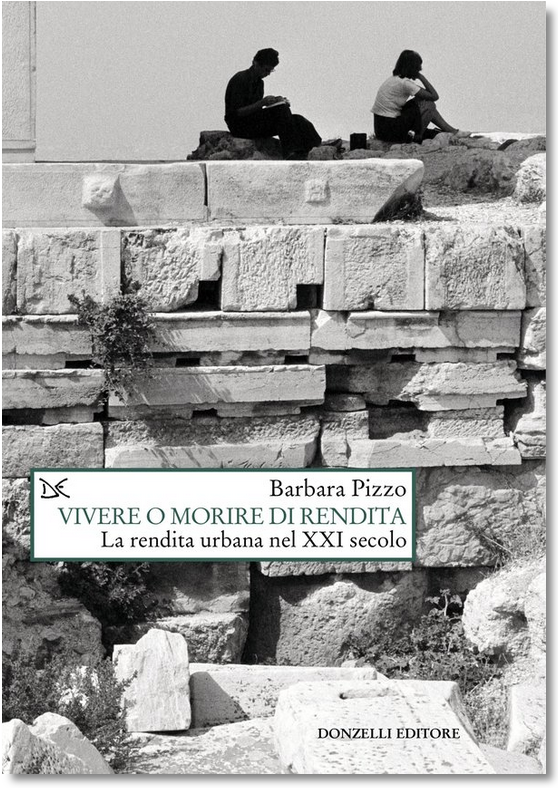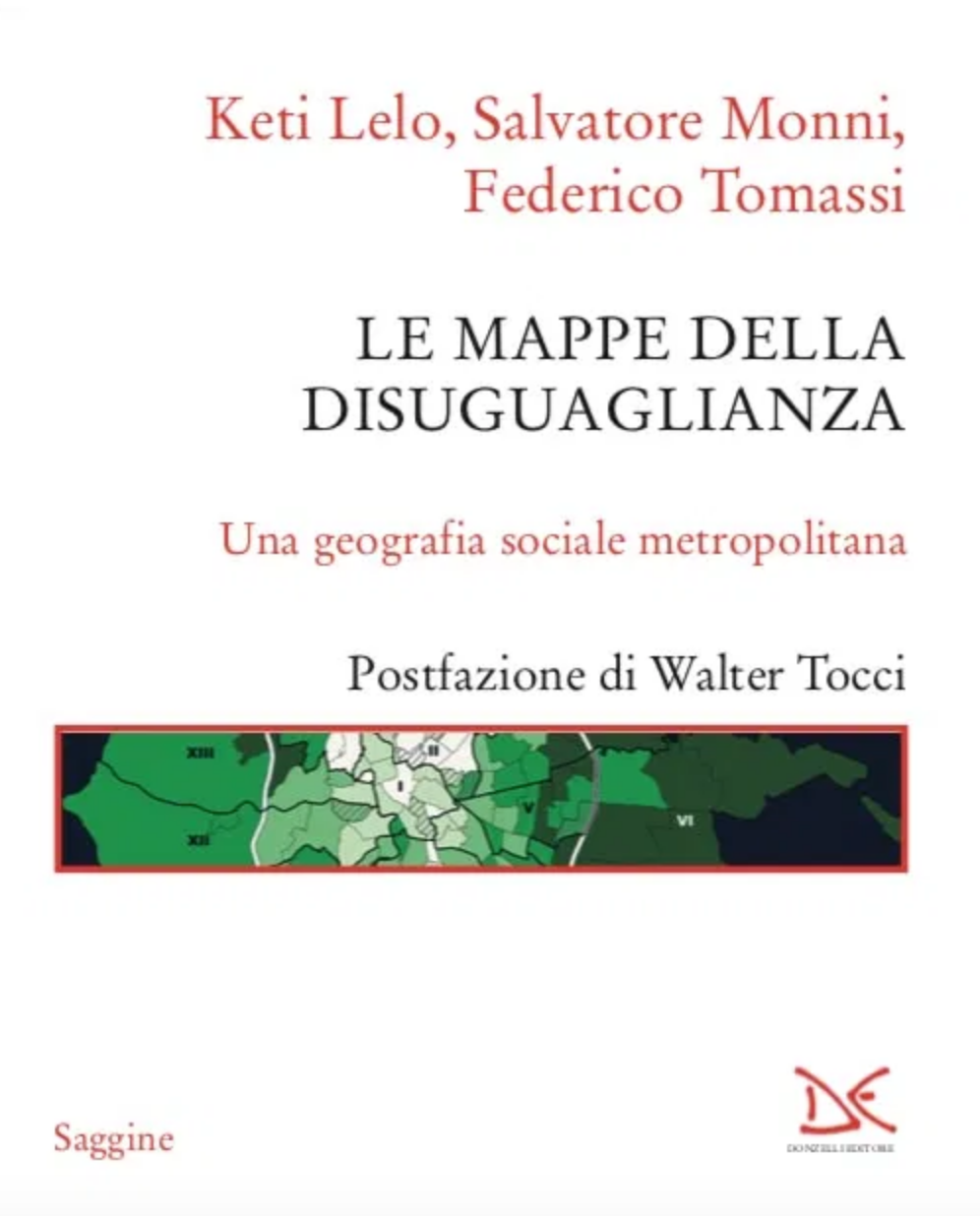- Home
- Chi siamo
- Chi siamo – il laboratorio
- Iscriviti alla newsletter
- Il Manifesto di Carteinregola
- Le nostre regole
- Rete di Carteinregola
- Le iniziative di Carteinregola dal dicembre 2020
- Tutte le nostre iniziative
- Fatti sentire! Impariamo a usare gli strumenti di comunicazione
- Censimento
- Piediperterra
- Piediperterra a Dragona e Dragoncello
- 1. Parco del Drago: appunti per una introduzione storica
- 2. Dragoncello: storia del Parco del Drago, Convenzione urbanistica PRU e progetti
- 3. Storia di Dragona
- 4. Dragona: il Museo D. Agostinelli
- 5. Dragona: il Punto Verde Qualità
- 6. Dragona: La stazione Acilia sud Dragona
- 7. Dragona – Dragoncello: Dorsale mare Tevere
- 8. Progetto Casale Dragoncello
- Piediperterra a San Lorenzo – Municipio II Roma
- Piediperterra a Testaccio
- Piediperterra a Casal Bertone – 5 luglio 2018
- Piediperterra 1
- Piediperterra 2 a Morena
- Spiazmoli! Piediperterra all’EUR 3- Spiazziamoli! IL PERCORSO
- Piedi per terra al Torrino sud il 20 gennaio 2017
- Piediperterra a Primavalle -28 aprile 2018
- Piediperterra a Dragona e Dragoncello
- Diario Presidio Campidoglio 2012-2013
- Dieci parole dell’ urbanistica
- Rassegna stampa
- Laboratorio
- La Mappa
- Calendario
- Istituzioni
- ISTITUZIONI
- Governo Italiano
- ROMA CAPITALE
- La consiliatura Gualtieri dal 2021
- Deliberazioni dell’Assemblea Capitolina dal 2021
- Deliberazioni della Giunta Gualtieri dal 2021
- Roberto Gualtieri Sindaco
- La Giunta Capitolina Gualtieri 2021
- Silvia Scozzese Vicesindaco e Assessore al Bilancio
- Sabrina Alfonsi, Assessore ai Rifiuti, Ambiente e Agricoltura
- Andrea Catarci Assessore al decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti
- Barbara Funari, Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute.
- Miguel Gotor, Assessore alla cultura
- Monica Lucarelli Assessore alle Attività produttive e Pari opportunità
- Alessandro Onorato Assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport
- Eugenio Patanè Assessore ai Trasporti
- Claudia Pratelli Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro
- Ornella Segnalini Assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture
- Tobia Zevi Assessore al Patrimonio e Politiche abitative
- Maurizio Veloccia – Assessore all’Urbanistica
- Assemblea Capitolina 2021
- Presidenti, Giunte, Consiglieri Municipi dal 2021
- Roma Capitale e CittàMetropolitana
- Le aziende partecipate del Comune di Roma
- Comune di Roma leggi norme e regolamenti
- La consiliatura Gualtieri dal 2021
- Elezioni a Roma
- Regione Lazio
- ISTITUZIONI
- PoliticaLab
- iDOSSIER
- Autonomia Regionale Differenziata, cronologia e materiali
- Modifiche al PRG di Roma
- PianoCasa/Legge rigenerazione urbana Lazio
- Progetto Porto turistico – crocieristico di Fiumicino – cronologia e materiali
- Affittacamere, case per vacanze, B&B a Roma e nel Lazio – cronologia e materiali
- Lago ex SNIA Viscosa – V Municipio
- Ex clinica Villa Bianca Cronologia
- Stadio Flaminio – II Municipio cronologia
- Circolo Poste e sotto ponte della Musica – cronologia e materiali
- Lago e area ex SNIA Viscosa – V municipio
- Regolamento del Verde di Roma
- PTPR – Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (del Lazio)
- PatrimonioComune cronologia materiali
- PUP Piano Urbano Parcheggi cronologia materiali
- ProgettoFlaminio
- DecretoTrasparenza
- V.I.A. Valutazione Impatto Ambientale
- Stadio Tor di valle cronologia
- Pineta di Villa Massimo (Punto Verde Infanzia) II Municipio
- Il Parco di Centocelle – V Municipio – cronologia e materiali
- Pianidizona
- PVQ
- MetroC
- Torri dell’EUR
- ForteTrionfale
- Autorecupero a scopo abitativo del patrimonio pubblico esistente – cronologia e materiali
- ATAC – cronologia e materiali
- BastaCartelloni
- iQuaderni
- Stadio Pietralata
- Modifiche al PRG
- Regolamento del Verde
- L’Italia non si taglia
- Giubileo 2025
- Urbanistica del Lazio 2023-25
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 1 (governo del territorio- interventi in zona agricola)
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 2 (rigenerazione urbana)
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 6 (valorizzazione degli immobili di proprietà pubblica)
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 7 (procedure di Valutazione Ambientale)
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 10 (strumenti attuativi)
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 13
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 15 (attività estrattive)
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 16 (aree sviluppo industriale)
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 17 (edilizia agevolata)
- Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 17 (edilizia agevolata)
- Home
- Chi siamo
- - Chi siamo – il laboratorio
- - Iscriviti alla newsletter
- - Il Manifesto di Carteinregola
- - Le nostre regole
- - Rete di Carteinregola
- - Le iniziative di Carteinregola dal dicembre 2020
- - Tutte le nostre iniziative
- - - Fatti sentire! Impariamo a usare gli strumenti di comunicazione
- - - Censimento
- - - - Comitatiromani
- - - Piediperterra
- - - - Piediperterra a Dragona e Dragoncello
- - - - - 1. Parco del Drago: appunti per una introduzione storica
- - - - - 2. Dragoncello: storia del Parco del Drago, Convenzione urbanistica PRU e progetti
- - - - - 3. Storia di Dragona
- - - - - 4. Dragona: il Museo D. Agostinelli
- - - - - 5. Dragona: il Punto Verde Qualità
- - - - - 6. Dragona: La stazione Acilia sud Dragona
- - - - - 7. Dragona – Dragoncello: Dorsale mare Tevere
- - - - - 8. Progetto Casale Dragoncello
- - - - Piediperterra a San Lorenzo – Municipio II Roma
- - - - Piediperterra a Testaccio
- - - - Piediperterra a Casal Bertone – 5 luglio 2018
- - - - Piediperterra 1
- - - - Piediperterra 2 a Morena
- - - - Spiazmoli! Piediperterra all’EUR 3- Spiazziamoli! IL PERCORSO
- - - - Piedi per terra al Torrino sud il 20 gennaio 2017
- - - - Piediperterra a Primavalle -28 aprile 2018
- - - Diario Presidio Campidoglio 2012-2013
- - - Dieci parole dell’ urbanistica
- - - - PTPR – il seminario del 1 luglio 2019
- - Rassegna stampa
- Laboratorio
- - associazione
- - - Gruppo lavoro mobilità
- - - - Rete ferroviaria metropolitana e rete di superficie
- - - - GRUPPO STUDIO Rete intermodale e nodi di interscambio
- - - - Scenari PUMS rete ferro metro tramviaria
- - - - TRAM
- - - - METROPOLITANE
- - - - nuovo contratto ATAC 2025-2027
- - - - Mobilità – infomobilità
- - - - Gruppo lavoro Mobilità – ciclabilità
- - - indirizzario
- - - Calendario
- - - - Calendario – eventi
- - - la Biblioteca di Carteinregola – per i soci
- - STRUMENTI PER CITTADINI ATTIVI
- - - Gestire il Calendario Gmail
- - - - Istruzioni condividere calendario Gmail
- - - - istruzioni gestione account posta Gmail – gruppi di contatti
- - - - Istruzioni per creare una pagina Facebook
- La Mappa
- - schema per le schede
- Calendario
- Istituzioni
- - ISTITUZIONI
- - - Governo Italiano
- - - - Governo Italiano
- - - ROMA CAPITALE
- - - - La consiliatura Gualtieri dal 2021
- - - - - Deliberazioni dell’Assemblea Capitolina dal 2021
- - - - - Deliberazioni della Giunta Gualtieri dal 2021
- - - - - Roberto Gualtieri Sindaco
- - - - - La Giunta Capitolina Gualtieri 2021
- - - - - - Silvia Scozzese Vicesindaco e Assessore al Bilancio
- - - - - - Sabrina Alfonsi, Assessore ai Rifiuti, Ambiente e Agricoltura
- - - - - - Andrea Catarci Assessore al decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti
- - - - - - Barbara Funari, Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute.
- - - - - - Miguel Gotor, Assessore alla cultura
- - - - - - Monica Lucarelli Assessore alle Attività produttive e Pari opportunità
- - - - - - Alessandro Onorato Assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport
- - - - - - Eugenio Patanè Assessore ai Trasporti
- - - - - - Claudia Pratelli Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro
- - - - - - Ornella Segnalini Assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture
- - - - - - Tobia Zevi Assessore al Patrimonio e Politiche abitative
- - - - - - Maurizio Veloccia – Assessore all’Urbanistica
- - - - - Assemblea Capitolina 2021
- - - - - - Commissioni capitoline 2021
- - - - - Presidenti, Giunte, Consiglieri Municipi dal 2021
- - - - Roma Capitale e CittàMetropolitana
- - - - Le aziende partecipate del Comune di Roma
- - - - Comune di Roma leggi norme e regolamenti
- - - - - Il nuovo Statuto di Roma Capitale
- - - Elezioni a Roma
- - - - Istruzioni per aderire alla Carta del candidato trasparente
- - - - Roma 2021 – candidati liste programmi materiali
- - - Regione Lazio
- - - - Elezioni Lazio 2023 – risultati ed eletti
- - - - - Le risposte dei partiti alle richieste di Carteinregola per le elezioni regionali 2023
- PoliticaLab
- iDOSSIER
- - Autonomia Regionale Differenziata, cronologia e materiali
- - Modifiche al PRG di Roma
- - PianoCasa/Legge rigenerazione urbana Lazio
- - Progetto Porto turistico – crocieristico di Fiumicino – cronologia e materiali
- - Affittacamere, case per vacanze, B&B a Roma e nel Lazio – cronologia e materiali
- - Lago ex SNIA Viscosa – V Municipio
- - Ex clinica Villa Bianca Cronologia
- - Stadio Flaminio – II Municipio cronologia
- - Circolo Poste e sotto ponte della Musica – cronologia e materiali
- - Lago e area ex SNIA Viscosa – V municipio
- - Regolamento del Verde di Roma
- - - Regolamento del Verde e del Paesaggio urbano – Domande & Risposte
- - PTPR – Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (del Lazio)
- - PatrimonioComune cronologia materiali
- - PUP Piano Urbano Parcheggi cronologia materiali
- - - PUP – riepilogo Delibera n.79/20017 con espunzioni
- - ProgettoFlaminio
- - DecretoTrasparenza
- - - FOIA –
- - V.I.A. Valutazione Impatto Ambientale
- - Stadio Tor di valle cronologia
- - Pineta di Villa Massimo (Punto Verde Infanzia) II Municipio
- - Il Parco di Centocelle – V Municipio – cronologia e materiali
- - Pianidizona
- - - Tutti i PDZ (dal sito del Comune di Roma)
- - PVQ
- - - PVQ: gli interventi
- - - - Punti verde qualità: gli atti pubblicati dal Comune
- - MetroC
- - Torri dell’EUR
- - ForteTrionfale
- - Autorecupero a scopo abitativo del patrimonio pubblico esistente – cronologia e materiali
- - ATAC – cronologia e materiali
- - - REFERENDUM ATAC 11 novembre 2018
- - BastaCartelloni
- - iQuaderni
- - - Migranti e rifugiati, cronologia e materiali
- - Stadio Pietralata
- - - Stadio della Roma a Pietralata – elaborati ed atti
- - - Stadio della Roma a Pietralata, il dossier con le osservazioni di Carteinregola
- - - - Stadio della Roma, non solo uno stadio (le osservazioni di Carteinregola 2.)
- - - - Stadio della Roma, quale verde pubblico (le osservazioni di Carteinregola 3.)
- - - - Stadio della Roma, la mobilità richiede importanti interventi e certezze (le osservazioni di Carteinregola 4.)
- Modifiche al PRG
- - Delibera di Adozione Modifiche Piano Regolatore 11 12 2024
- - Modifiche al Piano Regolatore, le osservazioni di Carteinregola
- Regolamento del Verde
- - Regolamento del Verde -materiali
- L’Italia non si taglia
- - Podcast L’Italia nonsi taglia
- Giubileo 2025
- Urbanistica del Lazio 2023-25
- - Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 1 (governo del territorio- interventi in zona agricola)
- - Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 2 (rigenerazione urbana)
- - Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 6 (valorizzazione degli immobili di proprietà pubblica)
- - Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 7 (procedure di Valutazione Ambientale)
- - Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 10 (strumenti attuativi)
- - Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 13
- - Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 15 (attività estrattive)
- - Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 16 (aree sviluppo industriale)
- - Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 17 (edilizia agevolata)